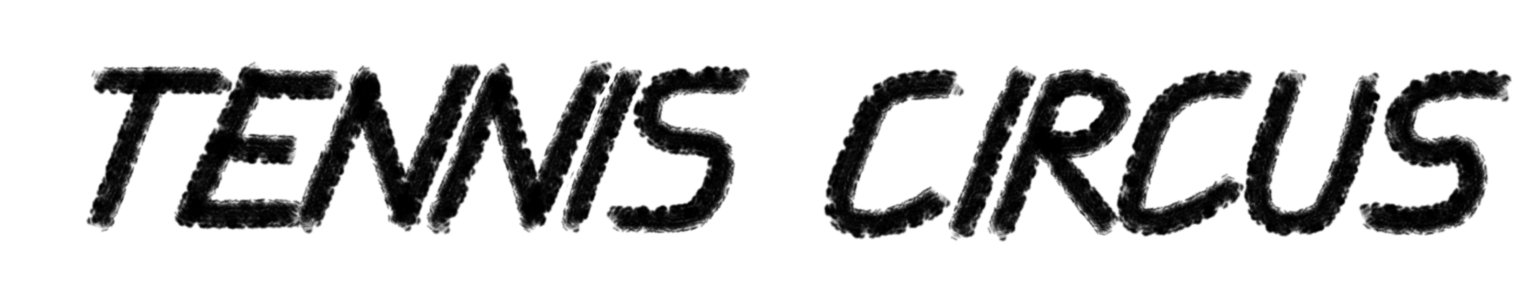La leggenda narra che da bambino Tom Simpson condividesse la stessa bicicletta con i fratelli e i cugini ma, a differenza loro, Tommy pareva essere nato per pedalare. Soprattutto, dentro di lui ardeva il sacro fuoco che caratterizza quegli esseri speciali, quelli destinati a compiere grandi imprese, quale che sia la disciplina che decidono di intraprendere. Tommy era competitivo per natura. Alcuni amici avrebbero raccontato che pure quando giocava a carte voleva vincere. In una Inghilterra all’epoca priva di ciclisti, in cui i ragazzini erano semmai propensi dedicarsi al calcio, quella sua abnegazione riversata sulla bicicletta, uno sport inderogabilmente legato al sudore e alla fatica, esprime più di mille parole il senso di sfida che albergava nella mente e nel cuore di Tom.
Nato il 30 novembre del 1937 a Haswell, cresce nell’altrettanto piccola Harworth, nella contea di Nottingham. A diciannove anni vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Melbourne. Due anni dopo si appende al collo l’argento ai giochi del Commonwealth. Se il passaggio al professionismo avviene nel 1959, è comunque nel 1961 che il nome di Tom Simpson balza di prepotenza all’attenzione generale quando al Giro delle Fiandre sconfigge il vento, il rivale con lui fuga, tale Nino De Filippis, e tutti gli inseguitori. Quel britannico dallo sguardo solare, impertinente, era un outsider e molti attribuirono la sua vittoria a un frainteso: il vento era talmente forte che i giudici di gara decisero di posizionare lo striscione d’arrivo in un luogo maggiormente riparato, seppure più distante dal punto atteso dall’italiano che si arrese in volata. In realtà, a differenza del britannico, De Filippis aveva semplicemente finito la benzina.
Se una brutta caduta alla Parigi-Roubaix avrebbe sfalsato l’intera stagione stagione di Tom, nel 1962 diviene il primo inglese a vestire la maglia gialla al Tour de France. L’ascesa, o per meglio dire, le conferme di Simpson si inanellano tra vittorie e piazzamenti di prestigio. Nel 1964 vince la Milano-Sanremo del 1964 segnando la media record di 43,420 km/h, nel 1965 trionfa al Giro della Lombardia e addirittura al Campionato del Mondo a Lasarte-Oria. Un successo, quest’ultimo che avrebbe spinto Elisabetta II a rendergli omaggio del titolo di baronetto.

Amava ridere, scherzare, le auto sportive, la bella moglie Helen e i suoi figli, Jan e Joanna. Nel suo profondo però c’era un aspetto che lo stava ossessionando: dimostrare al mondo il proprio valore. Quello era un ciclismo di un certo tipo, era roba da francesi, italiani, al massimo belgi. Tommy era un inglese e si sentiva ferito dai commenti spicciativi che spesso gli venivano riservati: un uomo fortunato, un corridore da corse di un giorno. In realtà Tom Simpson era una forza della natura, sospinto da volontà incrollabile, dotato di una esuberanza, di una generosità in gara che spesso lo aveva penalizzato sul più bello. «Sarei disposto a tutto pur di vincere, anche all’ipnosi»; disse in un’intervista pochi giorni prima di presentarsi al Tour de France del 1967, deciso come non mai.
I dubbi, gli interrogativi, le speranze, le ambizioni diventano un tutt’uno dopo la prima settimana. Tom Simpson è sesto nella classifica generale, ma è primo tra i favoriti alla vittoria finale. Mentresulle Alpi un forte mal di stomaco gli procura una crisi drastica con conseguente crollo in termini di graduatoria, il suo manager sigla il passaggio dalla sua attuale squadra, la Peugeot, all’Italiana Ignis. La sera del 12 luglio il suo compagno di stanza Colin Lewis racconta di aver assistito a un concitato alterco tra Tom e il suo manager, Alec Taylor. In ballo sembrano esserci gravi ripercussioni economiche nel caso la classifica non decolli. Qualche ora dopo avrebbero bussato alla porta due individuo pronti a vendergli tre tubetti di, Mickey Finns, ossia anfetamine, al prezzo di 800 sterline.
La tredicesima tappa del Grande Boucle, la Marsiglia-Carpentras, prevede 215 chilometri. Per arrivare è necessario svalutare il Mont Ventoux. Il Gigante della Provenza, come lo definiscono i francesi, vanta però appellativi ben più inquietanti. Il maestrale che soffia implacabile in concomitanza con l’ossigeno rarefatto creano sul Mont Ventoux un vuoto di vegetazione spaventoso e rendono il deserto che si posa al di sotto dei suoi 1912 metri quanto mai simile ad un paesaggio lunare da guadagnarsi il nomignolo di Monte Calvo. Non solo, il filosofo Roland Barthes avrebbe associato l’asprezza e l’ostilità che lo contraddistingue, riconoscendolo come il Dio del Male.

La partenza è stabilita preso il il santuario di Notre Dame di Marsiglia. Di prima mattina la colonnina di mercurio sfiora i 40 gradi e gli organizzatori pensano di alleviare quel caldo soffocante distribuendo foglie di verza da posizionare sotto il cappellino. Quando Tom Simpson afferra la sua foglia la intinge nella borraccia per poi agitarla sopra alla testa dei compagni, a mo’ di benedizione.
Ma quel 13 luglio va tutto male. Tom arranca sin dalle prime fasi, ma è alle soglie del Mont Ventoux che ha inizio il calvario. A causa del caldo insopportabile ha finito l’acqua e chiede a un compagno di passargli qualcosa da bere. Non ha niente nemmeno lui, ma da bravo gregario si ferma a un bar per scoprire di essere praticamente rimasto senza niente, eccetto una bottiglia di cognac. Tempo una decina di minuti e la passa al suo capitano che, dopo averne bevuto avidamente un sorso, la butta via. A salita iniziata prende dalla tasca uno dei tubetti comprati la sera prima e assume una pastiglia.
Quando inizia a zigzagare non sarebbe ancora troppo tardi per avere in salvo la vita, ma in quei momenti, forse Tom Simpson vede tutt’altro: vede Roger Pingeon, vede chi lo ha sempre sminuito, vede un futuro brillante. Quello era un ciclismo di un certo tipo, era roba da eroi. La gente che lo vede superare Lucien Aimar non lo riconosce: ha lo sguardo vuoto, assente, perso in una dimensione tutta sua. Ad un certo punto un altro ciclista gli porge la propria borraccia. Tom la rifiuta. Qualcuno dirà che non pareva nemmeno essersi accorto dell’offerta.
È a pochi chilometri dalla vetta quando cade una prima volta. Ordina al suo meccanico di rimetterlo sulla bici, o meglio, le sole parole che Harry Hall sente sono, «on, on, on…»; avanti, avanti, avanti. Insieme al manager del campione, Hall lo rimette in sella. La cima non sembra lontana. «Get me straight», tiratemi dritto; bisbiglia mentre stringe saldamente le mani sul manubrio. A quella cima non sarebbe mai arrivato.
Ancora qualche metro e Tom Simpson, il leone dello Yorkshire, cade una seconda volta. L’ultima. È un poliziotto a lanciare l’allarme che precede di qualche minuto l’arrivo del medico, Pierre Dumas, il quale trova Simpson riverso sulla banchina, ai lati della strada. Si accorge subito della gravità delle sue condizioni: gli pratica il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca, più e più volte. Per quasi un’ora. Finché richiede un elicottero. All’ospedale Parisien Libéré di Avignone sono le 18,30 quando l’organizzatore del Tour Felix Lévitan legge un comunicato: «Tom Simpson è morto alle 17,40».
Il travaglio del britannico però non era ancora finito. Nelle tasche della maglia vengono trovati tre tubetti sospetti. Sistemato nella cella n.3, l’autopsia rivela la presenza di anfetamina nel sangue. Erroneamente definito «la prima vittima del doping», solo nel tempo sarebbe stata rivalutata la sua figura in quanto l’anfetamina non uccide, semmai altera lo stato di percezione della fatica, innalza la soglia del dolore. Condizioni che, unite alla canicola, alla disidratazione e forse a quel sorso di cognac, ne provocarono un collasso cardiaco.
Perché la ancor più triste verità è che Tom Simpson fu una vittima del destino, del caso, o forse di sé stesso, della sua ambizione, del suo orgoglio, di quel meccanismo perverso che si innesca nel momento in cui un traguardo assume le sembianze di un’allucinazione.