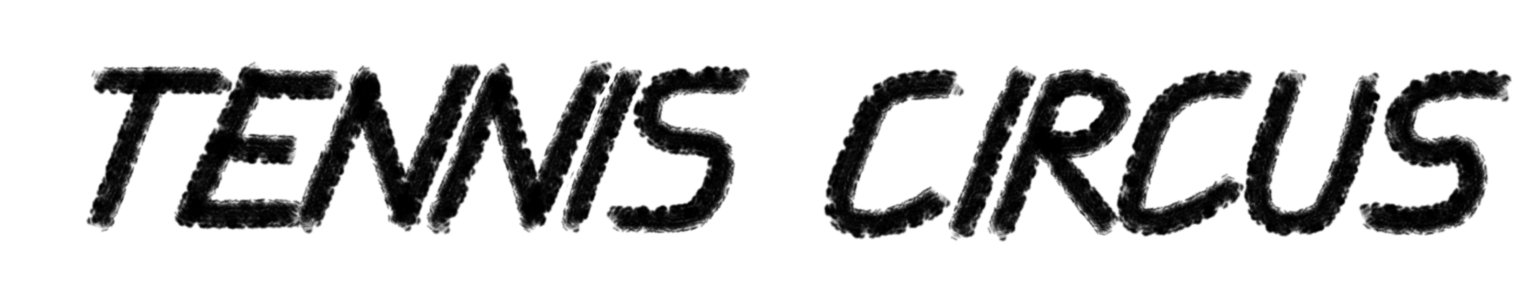Me l’ero appuntato in un angolo del cervello e per fortuna, grazie a un avventuroso incontro di neuroni, me lo sono ricordato al momento opportuno (sì, lo so, direte voi, bastava mettersi un promemoria o una sveglia, ma a volte bisogna affidarsi al puro istinto). E così, nella piena furia di un primo turno dell’Australian Open spezzato in due dal maltempo, con partite rimaste aperte sul più bello per oltre ventiquattr’ore, tra speranze, conferme, dubbi e delusioni, ho spostato la mia camera interiore sul challenger di Rennes dove, lontano da sguardi indiscreti, Jerzy Janowicz tornava ad approcciarsi alla materia dopo oltre due anni di inattività – il suo ultimo avversario, Kukushkin, sarebbe stato eliminato poco più tardi nella notte australiana, al quinto dopo aver rimontato da due a zero, ma questo è un altro destino.
Ci sono ritorni che avvengono in pompa magna, tipo l’I’m back di Michael Jeffrey Jordan, ce ne sono altri più discreti, ma è difficile immaginare uno scenario surreale come quello che ha incorniciato il nostro figliol prodigo polacco. L’ex numero 14 Atp è inquadrato alla lontana da una telecamera fissa all’interno di un rettangolo che non riesco nemmeno a visualizzare a schermo intero. Con questi due colori accesi e la pallina quasi invisibile, il tutto mi ricorda un videogame tennistico di vecchia generazione. Qualche applauso e un vociare denotano la presenza di pubblico, non incluso nella mia avara prospettiva. Insomma, un disastro estetico, un senso di vuoto e disperazione che per contrasto assume le fattezze di un gesto d’amore. Vedere un uomo che ha già sfiorato il cielo con un dito, un tipo che a volte pareva pure arrogante, che dopo essere stato ricacciato nei bassifondi dell’oblio si rimbocca le maniche e si butta a lottare nel fango… ecco questa è poesia, questa è una storia che mi piace.
Si riassapora il vecchio servizio possente (19 ace alla fine, con sette palle break salvate su nove concesse) e le bordate da fondo alternate a qualche improvvisa palla corta imbastita da lontano – non per stanchezza o per interrompere lo scambio, tant’è vero che lo fa fin da subito, come per provare tutto il repertorio -, non mancano le discese a rete avventurose come voli in picchiata. L’avversario, Tomas Machac, è un giovane proveniente dalla Repubblica Ceca che non ne vuole sapere di mollare. Ne viene fuori una partita tosta, che segue i turni di battuta senza troppi scossoni fino all’undicesimo gioco, in cui Jerzy mette la freccia, fa il break e va a servire per il set ma s’inceppa e si fa raggiungere al tie break, che poi ghermisce con autorità. Anche il secondo parziale giunge al tie break, con esiti opposti. Nel terzo round il polacco sale in cattedra, cincischia un po’ al momento di chiudere (da 5-2 a 5-4), ma alla fine fa suo il match.
Non ci sono inquadrature ravvicinate, non ci sono dettagli in hd dei gesti minimi e della mimica facciale, c’è solo la potenza verticale e rabbiosa dello smash finale, il resto è lasciato all’immaginazione.
Ovviamente non sarà facile tornare sugli antichi livelli né sui palcoscenici assaporati in gioventù, questa è solo la prima pietra della fabbrica del Duomo, ma di certo il nostro eroe non dimenticherà questa serata.
Ripetersi è complicato, specie dopo una lunga inattività. Per dargli supporto psicologico abbandono il tie break di Fognini e mi sintonizzo sul campo blu immerso nel verde acido che riesce a essere buio e abbagliante nello stesso tempo. Succede di tutto: due break per parte, un medical time out – problema al polso per Janowicz -, un tie break e persino un toilet break. Il primo set, lunghissimo e spezzettato, è preda di Lestienne, ventisettenne francese che ha vinto due challenger in carriera. Nel secondo parziale Jerzy lotta ma commette qualche errore di troppo – anche perché rifiuta con ogni mezzo lo scambio prolungato – e sembra avere meno energie dell’avversario, che chiude 6-4.
Insomma stavolta niente lieto fine per Janowicz, ma è stato bello leggere un nuovo capitolo.