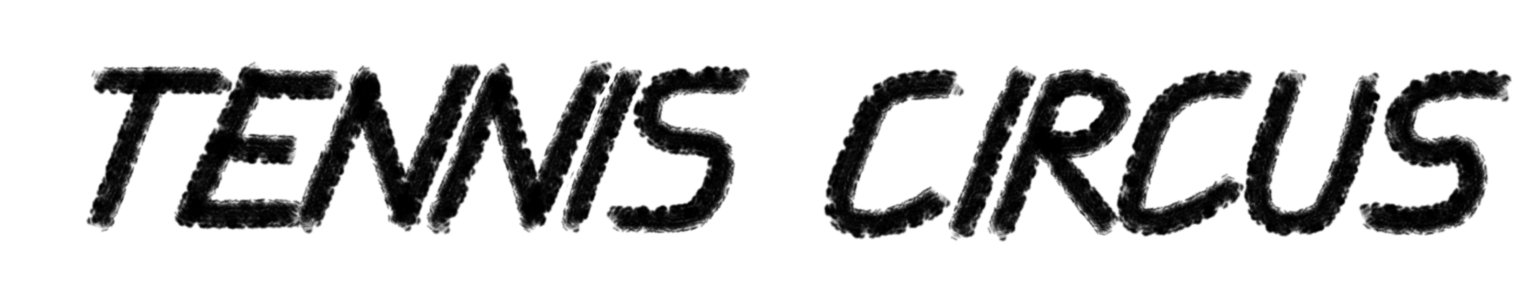Lo scambio parte, la risposta non è affatto male, lo slice basso però è molto insidioso. La palla finisce lunga, boato del pubblico. Stan, in quel suo completo che ti acceca gli occhi (ve lo assicuro!), alza le braccia al cielo. E’ campione degli US Open. Quando aveva raggiunto la finale, gli avevo augurato buona fortuna. Però la mia mente, adesso più che mai, non fa che ritornare maledettamente a quell’attimo. L’attimo in cui la sua assurda volèe aveva annullato il mio match point, e poi spazzato via anche me dalla partita. Ero stato ad un pizzico così dal battere il campione. Mark mi aveva dato del pazzo quando prima del match gli avevo detto che volevo impostare l’incontro sul rovescio di Wawrinka. “Sei un folle!”. Ma io nel mio rovescio in back ci credo davvero, è il colpo che mi piace giocare di più. Stan sono riuscito a davvero a metterlo in difficoltà, con slice esasperati, attacchi in controtempo e fiondandomi a rete appena ne avevo la possibilità. Diavolo, ce l’avevo quasi fatta! Poi si è spenta la luce. Ero arrivato al terzo turno già una volta qui, però rispetto a tre anni fa sono cambiate tante cose. Quella notte nello spogliatoio, sotto la doccia, mi è passata davanti tutta la mia vita, e soprattutto i momenti trascorsi su un campo da tennis.
Quand’ero ragazzino lo sport ha sempre riempito le mie giornate. Ricordo che a sette anni papà mi portò a giocare a squash al West Warwickshire Sports Club a Solihull. Era divertente lo squash. Soltanto per caso, qualche anno più tardi, presi per la prima volta una racchetta di tennis tra le mani. Mi divertivo da matti nel colpire quella dannata pallina gialla. Mi dissero che avevo talento e sarei potuto diventare un grande giocatore. A tredici anni lasciai la mia famiglia e mi trasferii alla LTA Academy. Era difficile per me, lontano dai miei e con il dovere di allenarmi ogni sacrosanto giorno. Ho sempre confidato nelle mie capacità ma già da ragazzino odiavo gli allenamenti. Ero piccolo e magrolino e probabilmente all’inizio ero il peggiore tra tutti quelli che si allenavano all’Accademia. Però non ho mai smesso di credere nei miei mezzi ed i risultati sono poi inevitabilmente arrivati.
Nel 2006 ero considerato uno dei migliori under 16 in circolazione ed ero fiero di questo. Avevo cominciato a giocare i primi tornei Juniores e non posso mai dimenticare quando mi tolsero una wild card a Wimbledon perché dicevano che ero uno “stupido” in campo. Potete quindi immaginare come già a partire dai sedici anni il mio rapporto con la Lawn Tennis Association non fosse dei migliori. Giocavo i tornei con i miei coetanei ma sostanzialmente mi annoiavo. Ero ancora un moccioso ma volevo già la gloria. Però quando mi chiamarono, anche solo per fare da sparring al team di Coppa Davis, devo ammettere che mi emozionai. Tim Henman era il mio mito quando ero ragazzino e poterci anche solo scambiare dividendo il campo significò molto per me. Voleva dire che ero sulla giusta strada e che forse potevo fare affidamento soltanto sul mio braccio.
Se sui campi mi scocciavo, mi allenavo poco e male e vincevo solo grazie al mio genio, al di fuori del tennis mi divertivo parecchio. Non ho alcun problema nell’affermare ancora oggi che preferisco un paio di birre ghiacciate ad un’ora di palestra. Sono nato e cresciuto con i pub che mi circondavano e per nulla al mondo scambierei una bionda ed una partita dell’Aston Villa. Nei locali mi conoscevano tutti e fare baldoria, bere e scatenarmi mi piaceva eccome. Ero un pivello che sapeva godersi la vita. Due anni dopo avermi negato un wild card, ritornai per giocare a Wimbledon. Era pur sempre Wimbledon Junior e quindi non mi passò neanche in mente di annullare la serata al night club, soprattutto prima di un match di doppio. Non so come ma beccarono me e Daniel, il mio partner, verso le cinque, sei di mattina ancora lì dentro. Qualcuno ci fotografò e spifferò tutto. La LTA mi tagliò i fondi, mi tolse le wild card e mi privò anche del centro tecnico per allenarmi fino a novembre. Io me ne infischiai e me ne tornai a Solihull. Volevo dimostrargli che valevo davvero e decisi di concentrarmi e giocare i Futures. Da agosto ad ottobre ne vinsi tre e furono costretti quasi a malincuore a darmi il premio “LTA Male Junior Player of the Year”. Avevo diciott’anni, ero numero 477 al mondo e pensavo lo stesso che niente avrebbe potuto fermare la mia ascesa.
Quello che accadde negli anni successivi a quei tempi non riuscivo a spiegarmelo. I tornei che giocavo non erano quelli che avevo immaginato, i giocatori nei primi cento mi distruggevano e vedevo che anche i miei coetanei, che avevo sconfitto agevolmente tra gli Juniores, mi prendevano letteralmente a pallate. Non volevo darmi per vinto nonostante mi allenassi male e sporadicamente, ma in quegli anni ricordo con grande emozione un evento: il mio esordio in Coppa Davis. Ritengo ancora oggi la Coppa Davis la competizione che più mi ha dato e che ancora oggi mi rende fiero di essere un giocatore di tennis. Persi contro Janowicz e mi infurai per questo. Ci tenevo troppo a fare bella figura all’esordio e invece persi nettamente. E poi ancora fui sconfitto da Przysiężny. Mi arrabbiai ancora di più quando venimmo sconfitti dai lituani. Persi entrambe le partite, nonostante la fiducia che capitan Lloyd aveva riposto in me. John dopo quella sconfitta rassegnò le sue dimissioni. Quattro match in Davis e li avevo persi tutti. Di solito me ne sbattevo delle sconfitte ma perdere quando rappresenti una nazione intera è diverso. Ti fa sentire davvero una merda. Metteteci pure che a dicembre la Lawn Tennis Association, sempre quella, dice che ho scarsa attitudine e mi taglia di nuovo i fondi.
Sempre e soltanto grazie al dono naturale che mi è stato dato nell’impugnare la racchetta nel 2011 quei fondi me li avrebbero ridati. E fu fondamentale per me conoscere una persona quell’anno: Julien Hoferlin. Lo avevano mandato dal Belgio ad aiutare la Federazione ed era diventato il mio coach.
Dell’anno successivo ricordo volentieri soltanto le mie prime due vittorie in Coppa Davis, contro la Slovacchia. Mi davano ancora fiducia nonostante avessi giocato dieci match a livello ATP e li avessi persi tutti. Questa volta non delusi le mie personali aspettative ed ottenni due vittorie contro avversari posizionati più di cento posizioni avanti nel ranking. Probabilmente fu l’unica soddisfazione dell’intera stagione.
La Federazione mi aveva detto che ormai ero soltanto un fuoco di paglia, che avevo talento ma che non avevo voglia di sudare per il tennis. Mi tolsero il sostegno di Julien ed io pensai seriamente di smettere. Senza il supporto della Federazione era un’impresa impossibile tirare avanti, tant’è che dovetti chiedere aiuto ai miei.
25000 £, i soldi che mi servivano per finanziare la mia stagione, erano davvero una grossa cifra da richiedere e non pochi dubbi si insinuarono nella mia mente: potevo farla finita e non sentire più le persone affermare che stavo sprecando un dono immenso: saper giocar bene a tennis. A me non è mai interessato nulla della gente ma stavo riflettendo seriamente sul mio avvenire. A tirarmi fuori dai guai fu di nuovo lei, la Coppa Davis. Il nuovo capitano, Leon Smith, all’ultimo e inaspettatamente mi convocò per giocare l’importante match contro la Russia. Io non mi feci trovare impreparato nonostante la chiamata last-minute. Giocai un match lottato con Tursunov, ma persi. Alla fine della prima giornata eravamo sotto due a zero. Ci serviva un miracolo. Quel che accadde fu chiamato “il Miracolo di Conventry”. Sul due pari giocai quello che è stato uno dei match che ricordo con più piacere, una partita che rievoca soltanto ricordi dolci. Donskoy era nella top-100, quella che io in quel momento vedevo soltanto con il binocolo. Per tutti qui in Gran Bretagna ero soltanto un sopravvalutato. Quando gli rifilai tre set a zero, dissero che la mia fu una vittoria “memorabile”. Soltanto in quel momento tutti si ricordarono che avevo talento, la stampa diceva che ero un eroe e la Federazione mi faceva i complimenti. Fino al mese prima non facevano altro che sputarmi in faccia e adesso mi osannavano. Chi invece mi fu davvero a fianco fu Leon. Grazie al suo intervento ripresero a garantirmi dei soldi e potei ritornare a lavorare con Julien. Non ebbi paura di dire alla stampa che odiavo gli allenamenti, che facessi male il lavoro del tennista e che se volevo nella loro fottuta top-100 ci arrivavo ad occhi chiusi. Giocai bene sull’erba, vinsi il mio primo match contro un top-50 e mi sentivo in fiducia. Agli US Open 2013 avevo il fuoco dentro e potei mostrare chi fosse davvero Daniel Evans. Sconfissi Nishikori e Tomic, non degli sconosciuti, raggiunsi il terzo turno e pensavo che fosse iniziata una seconda, se non una terza fase della mia carriera. Avrei dimostrato di non essere solo un buffone e il mondo intero si sarebbe inginocchiato al mio tennis.
Nell’anno successivo raggiunsi la mia prima semifinale ATP a Zagabria e raggiunsi il mio best ranking, numero 123. Restare concentrato su quel livello era per me troppo difficile a quell’epoca, avevo bisogno delle mie pause. Dopo aver perso al primo turno a Wimbledon, Julien ritornò a lavorare in Belgio e fu costretto a lasciarmi. In un’intervista disse che io potevo tranquillamente essere in top-60, ma che non ero in grado di sacrificarmi, che il tennis era soltanto una fase della mia vita. Ho provato a smentirti, amico mio. Questa palla gialla se non la mia ragione di vita, è diventata un’ossessione per me. Adesso che in top-60 ci sono arrivato non faccio che pensarti, ovunque tu sia. Se oggi hanno capito chi sono lo devo in parte anche a te.
Quello che mi è successo nei mesi seguenti poi a molti non interessava. Nessuno pensava che il mio ginocchio fosse distrutto e la stagione da buttare. Io so come sono fatto, ed avevo bisogno del tempo necessario per poter tornare. Credevano che Evans si fosse stufato di giocare i tornei. Idioti! Quando ho potuto riprendere a giocare era cominciato già il 2015, e dopo tre tornei il ginocchio continuava a tormentarmi. Sparisco per tre mesi, il ranking mi dice numero 772 al mondo. Sono un semi-pro. Se mi fosse accaduta una cosa del genere qualche anno prima avrei sicuramente mollato. Ma in quel momento non potevo farlo. Non dopo tutti i sacrifici del vecchio, che al lavoro si rompeva il culo per farmi giocare a tennis. Non dopo tutte le notti che mamma ha passato all’ospedale per farmi giocare a tennis. Non dopo che le persone più importanti della mia vita mi hanno detto che io a tennis ci sapevo giocare fottutamente bene. Mi sono messo l’anima in pace, sono ritornato a giocare i Futures nonostante ne avessi abbastanza e a Wimbledon ero nel tabellone delle quali. Mi becco un warning per scarso impegno in un match vinto, quando mi muore sul piatto corde una palla corta, quando ero sotto 0-5 nel secondo set, ma chissene. Persi al turno finale, ma mi sentivo bene. Avevo vinto 29 delle ultime 33 partite giocate. E dopo aver visto la Davis da lontano per un po’ di tempo, a sorpresa, come due anni prima, ritorno a giocare contro l’Australia. Questa volta ci stavamo giocando la finale però. Nonostante la mia sconfitta con Tomic, eravamo all’atto finale. Qualche mese dopo, pur non giocando, sono stato fiero di far parte del team che la Davis l’ha vinta, settantanove anni dopo.
Come tutti sapete in questo 2016 la mia testa ed il mio fisico insieme hanno funzionato bene, mi sono imposto di allenarmi per raggiungere gli obiettivi che alcuni pensavano fossero impossibili per me. Sono entrato nella top 100 prima e nella top 60 poi. Ho vinto tre Challenger, ho giocato con Roger Federer il terzo turno a Wimbledon sul Campo Centrale. Ho iniziato a giocare con continuità sul circuito maggiore e in Inghilterra hanno ricominciato a parlare di me. Ma a me sinceramente non interessa e non mi è mai interessato. Ripenso a quel passante di rovescio e quella volée di Stan. Esco dallo spogliatoio ed ho il sorriso stampato sulle labbra. Ogni santo ha un peccato, ogni peccatore ha un futuro. Lo diceva Oscar Wilde ed io me lo sono tatuato sull’avanbraccio, per non dimenticare mai tutto quello che mi è capitato.
Tutti hanno capito che se voglio,io, con una racchetta sono capace di spaccare il mondo intero. Ma resterò sempre Evo, il ragazzo che preferisce una birra ad un’ora di palestra.