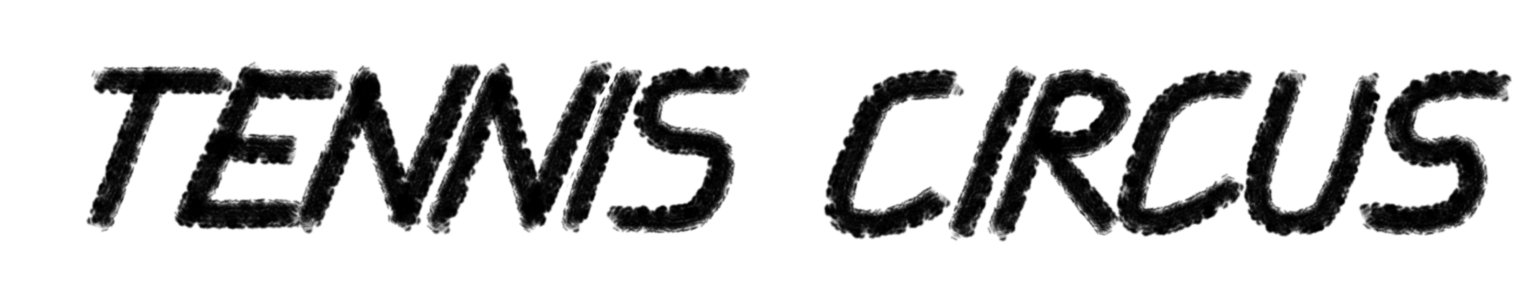Il ruolo di Jannik a Wimbledon dura come quello di una comparsa in un grande film, ed è un peccato perché giocare in total white su quel bel verde poesia è quanto di meglio si possa augurare a un tennista. E noi a Sinner vogliamo bene, nel caso non si fosse capito. Ma l’erba non perdona, si sa, e soprattutto l’erba non mente mai; e allora conviene ascoltare il suo verde(tto), leggerne tra i fili le motivazioni e accoglierne i consigli. Siamo nel tempio del tennis e un giovane apprendista può solo imparare la lezione.

Fucscovics non era l’avversario ideale per un primo turno ma non dovrebbe nemmeno spaventare, date le sue attuali condizioni, insomma sgomberiamo subito il campo da ogni alibi, primo fra tutti il sorteggio.
Poi, sempre per il capitolo attenuanti, possiamo spuntare la casella della pioggia che ha generato una lunga attesa, una certa paura di scivolare (giustificata dalle effettive cadute), tutti fattori che toccavano anche l’avversario. Jannik infatti ne parla ma non con l’aria di voler accampare scuse, più che altro alla ricerca di una risposta che non trova. Jannik ammette di non sentirsi sicuro e a proprio agio nei movimenti sul prato, di non essere riuscito a mettere in pratica quanto pianificato – per esempio scendere a rete con maggiore frequenza – e di aver perso via via fiducia nel servizio.
Peccato perché qualche sprazzo di ciò che potrebbe essere si è visto, specialmente nella fase centrale del primo set. Se entra la prima c’è la possibilità di comandare lo scambio, di gestire il ritmo e di accelerare in modo improvviso e definitivo. Ma non c’è stata continuità e oltretutto forse qualche dubbio frena la mente del giovane aspirante campione, qualche insicurezza insospettabile si insinua nei momenti importanti, soprattutto nelle sfide che lo vedono partire (a torto o a ragione) con il favore dei pronostici. Forse sono tremori fisiologici, forse figli di qualche giornata grama tipo la sconfitta con Hurkacz nella finale di Miami.

D’altra parte si sapeva che questo sarebbe stato un anno difficile almeno quanto il secondo album di Caparezza, la stagione in cui tutti ti aspettano al varco, tutti ti conoscono, tutti ti criticano. L’overdose di notorietà e l’indigestione di lodi (meritate) sono sempre insidiose, così come i vaticini di successi, di gloria imperitura e via dicendo. Lui è il primo a saperlo ed è pronto a pagarne il prezzo.
Per la sua età i risultati sono stati già ottimi (molti professionisti non raccolgono tanto nell’intera carriera, per dire…) ma questo zuccherino non può bastare perché lui giustamente guarda alle vette più alte e alla luna che le sovrasta.
Ciò che preoccupa è l’apparente assenza di progressi degli ultimi mesi, uno stallo se non addirittura un’involuzione: è il rovescio della medaglia di quella crescita devastante mostrata lo scorso anno. Era lecito aspettarsi altrettanto in questi mesi? Non so, di certo si fa sempre bene a sognare, ma questo non deve trasformarsi in disfattismo quando non arrivano le vittorie. Roma non è stata fatta in un giorno e così anche la formazione di un giocatore richiede tempo e pazienza – e i traguardi non sono mai stabili né acquisiti, basti vedere le tremende oscillazioni degli exnextgen: Tsitsipas preso a pallate dall’ottimo Tiafoe, Thiem entrato in depressione dopo aver vinto gli Us Open, Medvedev scomparso per tutta la stagione rossa, tanto per citare solo i primi e più facili esempi.
Se non altro le recenti delusioni toglieranno un po’ di pressione al ragazzo e gli permetteranno di crescere in santa pace, con tutti gli schiaffi del caso.
Secondo alcuni ha pochi margini di crescita ma le cose che può migliorare sono tante, non solo le ovvietà tecniche – di cui il servizio è la punta dell’iceberg – ma soprattutto il controllo dei match, di se stesso e dei proprio alti e bassi – in una parola: esperienza.

Per lui la ricetta è sempre la stessa, semplice e chiara: rimettere giù la testa e allenarsi duramente, perché – come ripete a mo’ di mantra, a dispetto della delusione – il lavoro alla fine pagherà.