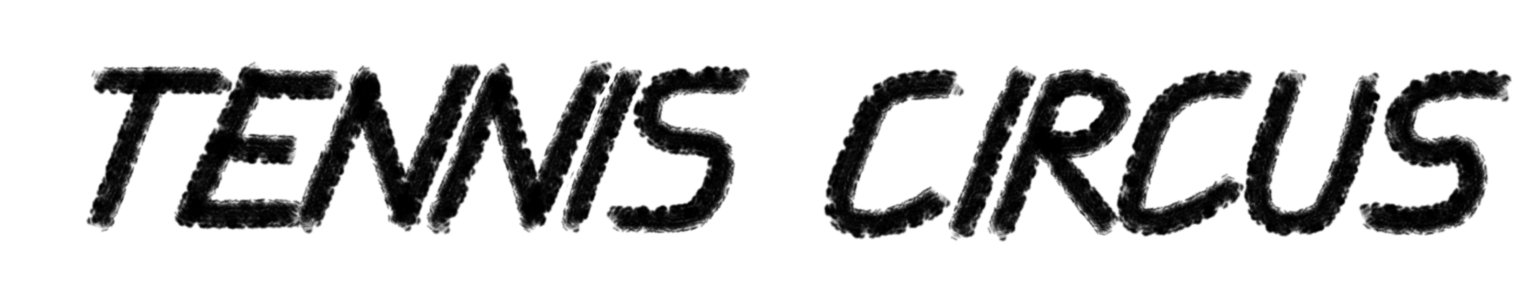Provate a mettervi nei suoi panni, poi me lo sapete raccontare come si sta. È la seconda volta nella sua straordinaria carriera che Rafael Nadal si trova in questo stato di impotenza e forse, delle due, è la peggiore.
La prima volta accadde sei anni fa, nel 2011, quando lo spagnolo consegnò lo scettro dell’ATP a Novak Djokovic dopo averci perso cinque finali consecutive tra Indian Wells e Wimbledon passando per Miami e, soprattutto, per Madrid e Roma. Ne sarebbe poi uscito, il maiorchino, con le ossa rotte anche a New York, sempre in quell’anno, e pure all’inizio del 2012 a Melbourne, allorché sfiorò la vittoria ma proprio averla persa, quella finale, 7-5 al quinto dopo circa sei ore di una battaglia quasi disumana gli fece capire che anche la sua ultima roccaforte, ovvero la lunga distanza, era crollata. Perché Nole gli aveva resistito e, sulla lunghissima distanza, lo aveva superato.
Quella fu la prima volta, per Nadal. Fu la prima volta in cui capì che qualcuno aveva trovato l’antidoto per il suo veleno. Che la sua proverbiale chela mancina scattava a vuoto. Che le sue palle, imbizzarrite dalle rotazioni impresse dalla Babolat, perdevano qualsiasi effetto se rimandate al mittente quando avevano appena toccato il campo anziché attendere che salissero malandrine verso il cielo. Che sempre quel qualcuno gli aveva rubato il brevetto della fase difensiva e ne aveva creato una versione 2.0 basata non più sul concetto di far tirare all’avversario sempre una palla in più costringendolo a prendersi rischi insopportabili bensì ribaltando il fronte, trasformando la difesa in attacco.
Quella fu la prima volta per Nadal, fin lì padrone assoluto dell’aspetto emotivo del gioco. Lui, capace di intaccare la fiducia di Federer fin dalle prime sfide tanto da dominarlo sul rosso e farne partita pari altrove, era quello che gli avversari sapevano di doversi sudare ogni quindici, anche il più apparentemente insignificante, perché il ragazzo di Manacor non gli avrebbe regalato nulla. Nulla. Il controllo della sfida, sul piano mentale, era sempre suo; in ogni momento, anche quando era in ambasce, Rafa poteva trovare il colpo che lo caricava e mettere pressione all’avversario e ribaltare il quadro psicologico del game, del set o dell’intera partita.
Non che vincesse sempre, sia ben chiaro! Fatta eccezione per la terra rossa, in cui praticamente non ce n’era per nessuno, lo spagnolo era vulnerabile sulle altre superfici ma non sembrava esserci, fino a quel 2011, una tipologia specifica di giocatore in grado di batterlo. Poteva essere un bombardiere come Fernando Gonzalez o Tsonga (Australian Open 2007 e 2008) o il connazionale David Ferrer che, sul cemento, gli creava sempre problemi (Us Open 2007 e Australian Open 2011) o ancora poteva soffrire i primi turni a Wimbledon contro avversari non troppo conosciuti (Gilles Muller e, in seguito, Rosol, Darcis, Brown). Episodi, insomma.
Poi arrivò Novak Djokovic, con quel suo rovescio lungo linea che cercava quello di Nadal e lo costringeva alla difesa in back, gli impediva di girare attorno alla palla e sventagliare di dritto. Nole che stava con i piedi sulla linea di fondo campo e lo sbatteva a destra e sinistra, facendogli perdere centimetri preziosi ad ogni colpo, fino all’esaurimento fisico e nervoso. Djokovic riuscì a spezzare l’incantesimo dell’indistruttibile Nadal andandolo a sfidare e battere sul suo terreno preferito, ovvero quello della regolarità (sia pur esasperata ai massimi livelli tollerabili) da fondo campo, e costringendolo a rivedere i suoi piani forse per la prima volta dall’inizio della carriera. Gli occhi dell’iberico che cercavano conforto in tribuna incrociando quelli dello zio Toni e non trovavano risposte furono l’emblema di quella lunga stagione ma Rafa riuscì a superare l’improvvisa inversione di tendenza, a metabolizzarla per tornare più forte di prima.
Accadde nel 2013, dopo una sosta forzata di oltre sette mesi. Dal Cile (Vina del Mar) alla Cina (Pechino), da febbraio a ottobre, Nadal inseguì il serbo fino in capo al mondo e, con 13 finali in 14 tornei (solo a Wimbledon perse prima, addirittura al primo turno con Steve Darcis), si riprese lo scettro e riuscì a togliersi (almeno temporaneamente) la scimmia dalla spalla battendo Nole in più di un’occasione. Poi sappiamo com’è andata a finire: l’anno successivo Djokovic tornò a dominare mentre lo spagnolo (complici anche gli infortuni) si perse via via in un dedalo di incertezze che gli fece perdere anche la supremazia sul rosso, oltre a farlo scivolare in classifica.
Bene, raccontato ciò che successe la prima volta, veniamo ai giorni nostri e proviamo a fare ciò che vi ho chiesto in apertura: mettiamoci nei suoi panni. Pur avendo dovuto sopportare di essere relegato al ruolo di outsider dall’avanzare di nomi “nuovi” quali Murray e Wawrinka, oltre ai soliti Djokovic e Federer (e, tuttavia, pur avendo continuato a godere di un credito smisurato soprattutto sulla terra), tra i tanti dubbi che avevano affollato la mente di Nadal una sola, grande certezza non lo aveva mai abbandonato: contro Roger ben difficilmente avrebbe perso.
Del resto, come dargli torto? Se hai affrontato 33 volte quello che tanti definiscono il più grande tennista della storia e lo hai battuto in 23 occasioni praticamente in ogni contesto, rischiando persino di togliere alla rivalità la sua propria essenza, non puoi pensarla diversamente da così. E non si cercassero giustificazioni nella superficie, in quanto l’estrema competitività dello spagnolo era palese anche sul duro (9-6) e sull’erba (1-2); solo con un tetto sulla testa lo svizzero sembrava inattaccabile, almeno fino alla sconfitta alle ATP Finals del 2013. E nemmeno l’ultimo head-to-head, che risaliva alla finale di Basilea 2015, aveva intaccato la fiducia di Nadal che, nelle peggiori condizioni possibili e pagando un divario di forma piuttosto evidente, era riuscito a strappare un set a Federer e a farlo penare per tre set.
Quello di Basilea era l’ultimo Federer targato Edberg, aggressivo e determinato a chiudere i punti in pochi e rapidi scambi ma ancora troppo passivo in risposta e in sofferenza nella ormai celebre diagonale rovescio suo contro dritto di Nadal. Per tutto il 2016 i due non si sono mai incontrati se non all’inaugurazione dell’accademia maiorchina di Nadal e non sembravano esserci i presupposti affinché uno dei due, meno che mai entrambi, potessero tornare protagonisti.

Invece eccoci alla seconda volta di Nadal, la seconda volta di quello sguardo perso nel vuoto e stavolta addirittura proprio nel momento in cui tutto pareva volgere al meglio. Nella partita di tennis più seguita nella storia dell’umanità (fatte le debite proporzioni, per trovare qualcosa di simile credo si debba tornare al 16 febbraio 1926 quando Suzanne Lenglen e Helen Wills si affrontarono al Carlton Club di Cannes) lo spagnolo avrebbe potuto al contempo ribadire la sua supremazia nei confronti di Federer e incamerare il 15° major in carriera. Nonostante la tattica spregiudicata di Federer, Rafa era riuscito a portarla per le lunghe e nel quinto set, avanti di un break, pareva proprio che non ci fossero campi, palline, anticipi, rovesci, Ljubicic o quant’altro in grado di rovesciare il dogma che stava alla base del Fedal. E cioè che alla fine, soprattutto negli incontri importanti, Nadal vinceva nove volte su dieci.
Ma lo spagnolo aveva fatto i conti senza l’oste e non riusciva a capacitarsi che quell’anziano rivale riuscisse, con la sua rapidità, a restringere il campo e colpire spesso la pallina con un anticipo tale da abbassarne sensibilmente le insidie, se non annullarle del tutto. Così, un minuto dopo l’altro, le certezze sono diventati dubbi e di nuovo certezze, stavolta uguali e contrarie. Quei cinque giochi, dall’1-3 al 6-3, hanno cambiato la storia per trasformarla prima in leggenda e poi in tendenza. La leggenda è quella del 18° slam di Roger Federer, la tendenza è invece quella ribadita nelle successive sfide di Indian Wells e Miami in cui, pur in condizioni a lui più favorevoli, Nadal ha finito per farsi dominare ancora più vistosamente. Con il quadro tecnico, anche quello psicologico tra i due è venuto a cambiare radicalmente e Rafa adesso è all’incirca nelle stesse condizioni del 2011: sfiduciato e incapace di prendere adeguate contromisure, ammesso che ve ne siano.
Al danno, poi, si è aggiunta la beffa della frustrazione di non potersi vendicare a breve, dato che lo svizzero sembra intenzionato a saltare tutta la stagione sul rosso e presentarsi (forse) solo a Parigi giusto per onor di firma ma con l’obiettivo preciso di preservarsi per l’erba tedesca e inglese. Con Murray e Djokovic afflitti da malanni veri o presunti, Nadal è stato a pochi passi dall’ennesimo rilancio intriso della sua celebre propensione alla lotta e invece ha finito per creare (o ricreare) un mostro, elevando alla potenza i già enormi meriti di Federer e rilanciandone suo malgrado la candidatura a GOAT.
Da giorni chi parla di tennis non fa che parlare di Federer e del suo acerrimo rivale, finalmente trasformato da carnefice a vittima per la pazza gioia dei milioni di tifosi dell’elvetico sparsi per il mondo. Ma attenzione a dare nuovamente per finito lo spagnolo. Quando vede rosso, il toro si infuria e sfonda gli steccati. Ad attendere il mancino di Manacor c’è l’ipotesi di quella che in campo calcistico sarebbe la stella, ovvero il decimo titolo al Roland Garros. Anche con un Federer a mezzo servizio (ammesso che lo sia, visto l’effetto che ha avuto su Roger la pausa precedente), non mancheranno i grattacapi per Nadal ma, ne siamo certi, non saranno nemmeno lontanamente paragonabili a quelli che lui creerà agli avversari.