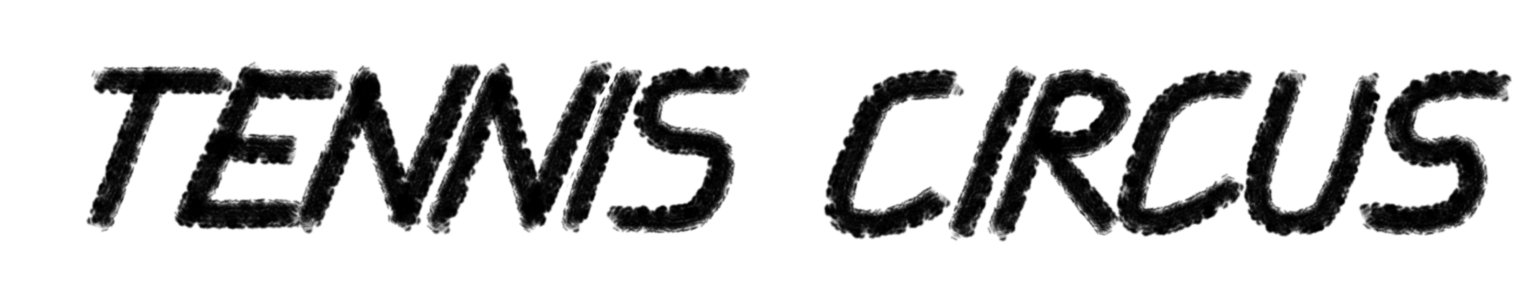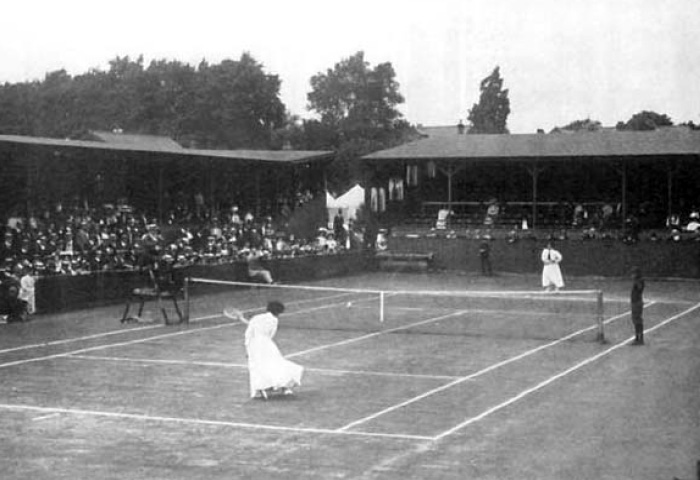Un po’ come accadde a Iva Majoli in quello che appare come un lontanissimo e annebbiato 1997 quando la sua vittoria al Roland Garros l’avrebbe fatta passare alla storia non tanto come una campionessa slam quanto come “la croata che impedì a Martina Hingis di realizzare il Grande Slam”, diciotto anni dopo Roberta Vinci ha prenotato il posto, apparentemente impossibile da riservare, di outsider capace di infrangere il sogno della n.1 del mondo Serena Williams. Lei, la portentosa quasi trentaquattrenne nativa di Saginaw, l’infanzia trascorsa a Compton, una scalata verso l’Olimpo fortemente voluta dal padre pigmalione, un visionario per alcuni, uno Svengali per altri. Lei, Serena, perennemente a se stante eppure volenti o nolenti unita per l’eternità alla sorella Venus, sul tetto del mondo e puntualmente in lotta per contendersi slam contro “il resto del mondo”, da tempi immemori, ossia diciotto anni. Lei, Serena l’imbattibile, almeno si credeva, negli appuntamenti che contano, uscita sconfitta non da un campo qualsiasi, bensì da quell’Arthur Ashe Stadium che è stato sei volte suo senza però esserlo mai stato in pieno, perché Serena Williams mai è stata pienamente amata e capita in patria e mai lo sarà; ebbene battuta non da quella Victoria Azarenka da molti ritenuta la vera e propria mina vagante “anti-Grande-Slam”, non da Simona Halep da molti attesa al grande salto, non da Svetlana Kuznetsova, sempre capace di quel guizzo che è marchio di fabbrica delle fuoriserie, no, da una giocatrice “come tante”, seppure non proprio come tutte, da una Roberta Vinci, una data per “finita“, una considerata “più una doppista che una singolarista”.
Insieme al sogno di Serena Williams va in frantumi un capitolo di storia. Nell’uscita dal campo di Serena Williams, mentre il pubblico già simpatizzava con la sua esecutrice, c’é tutta la crudeltà dello sport, spesso metafora di vita e che di conseguenza porta con sé tutta la precarietà della vita. La donna di ferro che esce di scena insieme ad un miraggio svanito, dissolto in una bolla di sapone, un appuntamento con la storia declassato a banale news che rimbalza dagli Stati Uniti alla Russia, dal vecchio continente all’Australia. Serena Williams si arrende ed insieme a chi esulta e si dispera si ritaglia uno spazio nel kolossal il rincalzo di turno, quello che per scrivere la storia deve scarabocchiare l’epopea altrui; con tutto il rispetto s’intende.
Addio Grande Slam dunque. E sono in tanti a gioire, a non capire che quando accadono certe cose non esistono bandiere o nazionalità, nemmeno antipatie personali, ma solo una donna che sovrasta tutto e tutti, irraggiungibile e indomabile, a cui tutto le andrebbe concesso e perdonato, siparietti e presunte sceneggiate comprese. C’é addirittura chi si permette di beffeggiarla perché ha risposto infastidita alla stupida stampa, al solito giornalista stolto e inconsapevole di inquinare il mondo, chi la deride come a dire rassegnati, fattene una ragione. Individui che non hanno capito niente di Serena Williams. Perché Serena Williams sì, se ne farà una ragione ma non si rassegnerà mai, come non si è mai rassegnata dall’accettare di essere stata preferita ad una biondina belga in una finale, in casa sua, a Indian Wells, come non potrà mai accettare di essere sempre stata preferita alla Jennifer Capriati di turno, alla Lindsay Davenport di turno, vuoi per bassezze razziali, vuoi perché Serena ha portato in campo tutta quella rabbia che in molti non volevano vedere, lei che ha “sporcato” il nobil gioco con presunti match decisi a tavolino quando dall’altra parte della rete c’era la sorella, lei che non si è mai vergognata di urlare quanta sana cattiveria le covasse dentro.
D’altra parte c’é chi si dispera. «Se lo sarebbe meritato», scrivono o dicono. Ed ecco che allo stesso tempo sarebbe ipocrita non ammettere che, per quanto leggendaria, un suo Grande Slam avrebbe pouto evocare colori non completamente “vivi”, non pienamente appaganti. Perché all’improvviso si potrebbe essere assaliti dal bisogno di trovare conforto nei numeri e allora rielabori che Serena Williams è diventata professionista appena quattordicenne, nell’ormai lontanissimo 1995. Per vincere la sua prima prova Slam ha dovuto attendere solo quattro anni, quando all’US Open del 1999 diede forse il colpo di grazia psicologico a Martina Hingis. È un caso che tra il 1997 e il 2009 Serena abbia vinto undici titoli slam, mentre tra il 2010 e il 2015, quindi in meno della metà del tempo, se ne sia intascati addirittura dieci? È forse un caso che quando nella prima decade del 2000 Serena veniva sconfitta chiunque scriveva, diceva e pensava che la statunitense aveva semplicemente cozzato contro un’avversaria che l’aveva battuta, mentre da qualche anno a questa parte la sensazione, quando perde, è quella che sia stata Serena Williams a “auto-depennarsi”? Perché chiuso l’almanacco, ti rendi conto che non c’è nessun conforto nemmeno nei numeri. Che questi dieci slam dal 2010 in qua avrebbero addirittura potuti essere undici, dodici, forse pure quindici. Dal 2010 è cambiato il vento e i “pezzi da 90” capaci di tener testa a Serena Williams si sono ritirate o hanno perso qualcosa per strada, chi più o meno irrimediabilmente. Che Serena Williams non abbia rivali perché non ci sono più le sue rivali. Che il mito dell’imbattibilità di Serena Williams sia una beffa del destino, in quanto imbattibile Serena non lo era nemmeno negli anni d’oro ed è alquanto sospetto lo sia diventata over 30. Che Serena Williams, al di là dei numeri, al di là del fatto che sia o meno la più forte di sempre, è una campionessa leggendaria che da cinque anni scrive le pagine della sua epopea in un regno privo di pathos.
Serena Williams non ha mai giocato tanto male nella sua carriera come nell’arco di questo 2015, tra l’altro una stagione in cui quasi sempre è stato espresso un livello di gioco di una povertà disarmante, in cui ls yankee ha vinto l’Australian Open contro un’avversaria, Maria Sharapova, che non la batte dal 15 novembre 2004 perché ogni qualvolta se la ritrova al di là della rete ha un blocco mentale, dove al Roland Garros si è trovata in finale “un prodotto di questi tempi” ossia Lucie Safarova, in quanto le sole due giocatrici capaci di impensierirla al Roland Garros, ossia Sharapova e Svetlana Kuznetsova, erano la prima era influenzata e la seconda reduce da un infortunio che le ha compromesso di presentarsi a Parigi in forma, dove a Wimbledon si è trovata impegnata in un ultimo atto contro una giovane quanto “normalissima” promessa quale Garbine Muguruza ed eccetto la semifinale stravinta contro la Sharapova ha tentennato e zoppicato qua e là.
Se lo sarebbe meritato quindi, questo Grande Slam? No, obiettivamente no. Se lo sarebbe meritato se fosse riuscita ad avvicinarsi a una simile impresa entro il 2010, ai tempi di Justine Henin e Kim Clijsters, di Jennifer Capriati, Lindsay Davenport, Amelie Mauresmo, Martina Hingis e dell’Armata russa capitanata da Sharapova e Kuzanetsova. Ma in quegli anni Serena Williams non avrebbe avuto le armi necessarie per avvicinarsi a questa impresa. E di conseguenza questo Grande Slam sarebbe stato l’apoteosi di un bluff, e non parlo di Serena sia chiaro, ma del contesto in sé. Nemesi storica ha voluto che ad impedire il tutto sia stata una giocatrice lontana anni luce dai sacri luoghi dove banchettano gli dei, quei solisti che hanno chiuso la loro carriera dall’alto di due, cinque, sette titoli slam; quelle compagne di viaggio di Serena Williams distaccate nel palmares, forse meno forti, di certo più demotivate, divenute spettatrici di uno spettacolo di cabaret che ha caricato quella Serena, ora quasi imbattibile ma che sarebbe regolarmente battuta dalla Serena pre-2010, di una tensione impossibile da gestire e a New York disintegrabile da almeno una cinquantina di giocatrici. E nemesi storica volle che in questo dannato giorno, in questo sabato 11 settembre 2015, non sia stata scritta nessuna pagina di storia trionfale, bensì la cronaca di una amara e prevedibilissima disfatta.