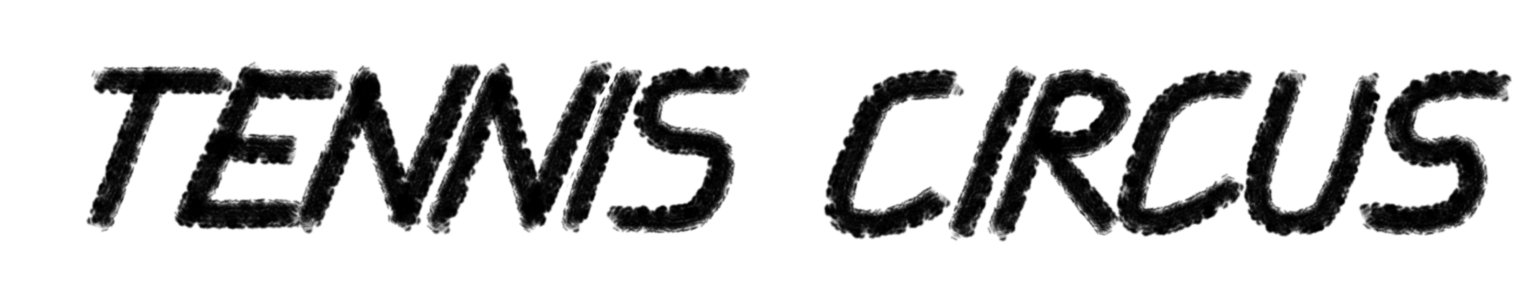Nel bel mezzo di un match, magari di una finale Master1000, ecco che Djokovic chiede l’intervento del suo coach: il buon Marian Vajda, rispolverato per l’occasione, scende a suggerire a Nole cosa fare (Pepe Imaz permettendo, ovviamente). Ce la immaginiamo questa scenetta? Francamente no, almeno secondo il vostro scriba, s’intende.
Ne avevamo già parlato qualche tempo fa con questo articolo di Simone Marasi. Se nel tennis femminile questa pratica è già diventata piena consuetudine, nel tennis maschile la discussione è aperta. In nome della parità dei sessi, e non certo per farne una questione ideologica, la regola andrebbe estesa a tutto il tennis professionistico: attualmente, guardando freddamente le cose, la regola estesa solo alle donne ne sancirebbe una sorta di inferiorità tattica rispetto ai colleghi uomini. Peggio sarebbe a voler considerare il circuito WTA una sorta di laboratorio sperimentale.
Ma chi vi scrive pensa che il coaching andrebbe rigorosamente vietato nel tennis. La sua natura di sport individuale, di luogo in cui si pensa, perché nella sua natura vi è proprio il pensare, tra un punto e l’altro, il rimuginare con se stessi, l’analisi costante punto dopo punto di quello che è successo. Scopriremmo decisamente la nota acqua calda se affermarssimo che il coaching nel tennis non esistesse, vero zio Tony? Ricordiamo i noti sistemi di comunicazione ideati da Ion Tiriac, che usava i suoi famosi baffi per dare suggerimenti ai suoi pupilli. Al di là di questi ricordi, il cui sapore appare quasi folkloristico oggi, le partite si preparano, gli avversari si studiano anche con l’ausilio delle nuove tecnologie: video, statistiche, proiezioni. Oggi il coaching si è evoluto: l’allenatore è un professionista che ha competenze che spaziano dalla tecnica pura alla psicologia. La qualità del giocatore emerge proprio durante il match, nel far tesoro di quanto pianificato in relazione a quello che sta accadendo in campo, mettendo in mostra le abilità del professionista di amministarsi sia psicologicamente che tatticamente.
L’intervento dell’allenatore in uno sport individuale come il tennis appare quindi una sorta di diminutio del giocatore stesso. La trance agonistica, l’abilità di portare a casa un match che va male è tutta del tennista, e sarebbe mortificata dall’intervento attivo dell’allenatore durante l’atto agonistico, attribuendo a quest’ultimo un ruolo ulteriore durante la partita, facendolo diventare protagonistica quasi quanto il giocatore stesso, magari portando gli allenatori di tennis ad un ruolo ancora più evidente e magari divistico, come accade del vituperato mondo del calcio. E francamente, sarebbe doveroso continuare a marcare questa differenza, in tempi di omologazione sportiva spesso orientata al ribasso tattico, tecnico ed etico.