“Il tennis mi piace, ma non è tutto. Limportante è vivere intensamente. Perché quello che è stato non tornerà più e nessuno sa cosa succederà domani”.
In questa frase è racchiuso Marat Safin, ex numero 1 del mondo, ex enfant prodige e terrible, che nel 2000, a vent’anni, sull’Arthur Ashe Stadium di New York, stravolse il tennis, lo riscrisse a suon di dritti e rovesci prendendo letteralmente a pallate la leggenda vivente Pete Sampras che a fine partita rimase visibilmente turbato e sconvolto, lui che arrivava da 8 finali del Grande Slam vinte consecutivamente e che aveva messo il suo settimo sigillo a Wimbledon pochi mesi prima.
Safin, quel giorno, fu spietato, ribaltò il cemento del Queens e baciandolo a fine gara appose il suo marchio di fabbrica, quel talento fulmineo tanto nei colpi quanto nel destino. Fu una toccata e fuga, una poesia, non una sviolinata, non un ipnotico riff, ma l’impeto delle migliori orchestre che va in crescendo, una musica che si fa alta, nei volumi e nelle frequenze, un gran finale.

Come prima di lui, in letteratura, il sedicenne Arthur Rimbaud, come nel teatro l’avvento, in Francia, di Antonin Artaud e in Italia di Carmelo Bene, personalità e talenti in grado di bruciare le tappe, cambiare in modo netto e definitivo il concetto di arte e tagliare i ponti col passato, Safin, da atleta, su un campo da tennis, riuscì a cambiare le carte in tavola, rivoluzionò per due ore scarse quello sport dominato in lungo e largo da Sampras, portò a scuola uno dei migliori giocatori della storia del tennis e toccò la corda più alta, quella dell’immortalità, mostrando ai 24. 000 paganti e ai milioni davanti alla televisione come si poteva non solo fare arte colpendo una pallina da tennis, imprese già riuscite allo stesso Sampras e ad Edberg prima di lui e, qualche anno dopo, ad un elvetico di cui adesso mi sfugge il nome, ma anche come si dipinge dalla linea di fondo per ore ed ore senza sbavare un colore, senza sbagliare una virgola. Mostrò ciò che fino ad allora era stato tabù, un gioco sconosciuto, ingiocabile, inarrivabile. Non inventò nulla, giocò semplicemente da un altro pianeta.
Il 10 settembre del 2000 il russo fu autore di un autentico capolavoro: 6-4, 6-3, 6-3 al maestro Sampras. Un’impresa che valeva e ancora vale, non tanto per il punteggio ma per come è maturato, quasi come un Vermeer od un Monet, opere d’arte esposte a New York al Metropolitan Museum Art. Museo del tennis dite? Di più. Quel pomeriggio di settembre Safin, quasi come fuori da se stesso, al di sopra dei suoi stessi pensieri, produsse tennis, giocò la partita perfetta, fu artista indimenticabile, costruì con nonchalance la propria fortuna e la propria rovina, pose per se stesso l’asticella su un pianeta che sembrava avere in tasca ma che in realtà, alla lunga, si rivelò troppo lontano, inabitabile.
Impossibile non concordare con ciò che ebbe da dire su quella finale e su quel modo di giocare di Safin Gianni Clerici anni dopo: “Safin di quel giorno fu probabilmente, il miglior tennista dell’ultimo decennio. Destinato a non ripetersi per ragioni che uno psicoterapeuta saprebbe meglio analizzare dello scriba”. La mente di Marat Safin era più delicata e complessa del “punto, linea e superficie” di Kandinskij, uno spruzzo di follia e di rabbiosa arte alla Jackson Pollock gettato sui campi da tennis, una meteora che passa e fugge, un fuoco d’artificio che raggiunge il punto più alto del cielo ed esplode lasciando agli astanti lo spettacolo di un ispirato, infuocato e lento declino, proprio come disse della vita il poeta e scrittore Jack Kerouac.
Safin fu questo: esplose in un attimo, sembrò sparire, diede un ultimo colpo di bellezza ed intensità inaudite e poi svanì, lentamente, lasciando al pubblico i detriti del suo talento, del suo non poter essere più di quello che era, dell’uomo che nonostante tutto era arrivato in cima al mondo. Pazzo, ironico, sorridente, più russo di un verso di Esenin, Safin ebbe in dono un talento che avrebbe fatto rattrappire perfino la mano di Picasso ma una mente umanamente fragile e contorta che lo condusse, anni dopo, ad una resa semplice e tranquilla, senza lacrime, senza inutile clmore.
Risse, dritti, rovesci, battute, donne, servizi velocissimi, racchette distrutte, gioco d’azzardo, spettacolo in campo, tante distrazioni, da una parte un atleticismo che poteva muovere il mondo a piacimento, dall’altra un mondo velocissimo fatto di realtà, passioni, pensieri, problemi, voglie e manie. Lui era di più, più del tennis in un certo del senso, qualcos’altro. Safin non era il tennis. Non aveva la sicurezza che aveva Roger Federer, il genio indisturbato che era toccato in sorte allo svizzero, quel sublime stare in campo come una divinità. Non si era cucito addosso le vesti del prescelto, ci aveva provato ma erano costumi che gli stavano o troppo grandi o troppo stretti.
Non aveva a disposizione l’universo sul quale poteva contare lo svizzero, Safin aveva le stelle. Safin era umano, in quegli anni, il primo degli umani, il più brillante, il più interessante, colui che sapendo benissimo di essere in corsa non verso la genialità di anni di dominio ma bensì verso una dura realtà, con talento ingestibile e sorriso beffardo si pose in mezzo tra il dominio di Pete Sampras e quello di Roger Federer, spezzando qualche catena, finendo intrecciato a quelle più spesse e pericolose della sua mente, per poi tirarsi fuori da tutto il pandemonio di bellezza sportiva e confusione creata con un ultima opera d’arte, firmata in Australia nel 2005 dove non ce ne fu davvero per nessuno.

Con la racchetta tra i denti, risorto, ispirato, alto tanto quanto la prosa di James Joyce, in semifinale battè Roger Federer 9-7 al quinto set in una delle partite più belle di sempre per poi sbarazzarsi in Finale del padrone di casa Lleyton Hewitt in quattro set. Si prese la sua ultima vittoria in un torneo del Grande Slam, l’ultimo acuto, l’ultima scintilla. Le braccia al cielo, ancora una volta, dopo cinque anni dalla prima volta. Imbattibile eppure alla fine sconfitto, bello, russo, vittima di se stesso eppure vincente, era Marat Safin. In campo forte come la lingua di Majakovskij, fuori delicato come il cuore che il poeta si perforò con un proiettile nel lontano 1930, ha assomigliato ad un gioco impossibile, ad un tennis completo, ha fatto e disfatto il cemento con un rovescio che tra il 2000 ed il 2005, i suoi anni d’oro, poteva tranquillamente essere nominato patrimonio dell’Unesco.
Poteva essere un Dio in terra, Safin, ma alla fine fu “solo” un uomo in un cielo di talento, dal quale fu costretto a scendere per giocare a tennis alternando paradiso ed oblio: non arrivò mai dove avrebbe potuto ma illuminò questo sport come pochi, come un fulmine che stanco della durata del sole ruba la luce e acceca il cielo per poi morire. Imbattibile, dicevamo, eppure alla fine sconfitto. Vittima di se stesso eppure vincente, senza colpe.
Alessandro Mancinelli
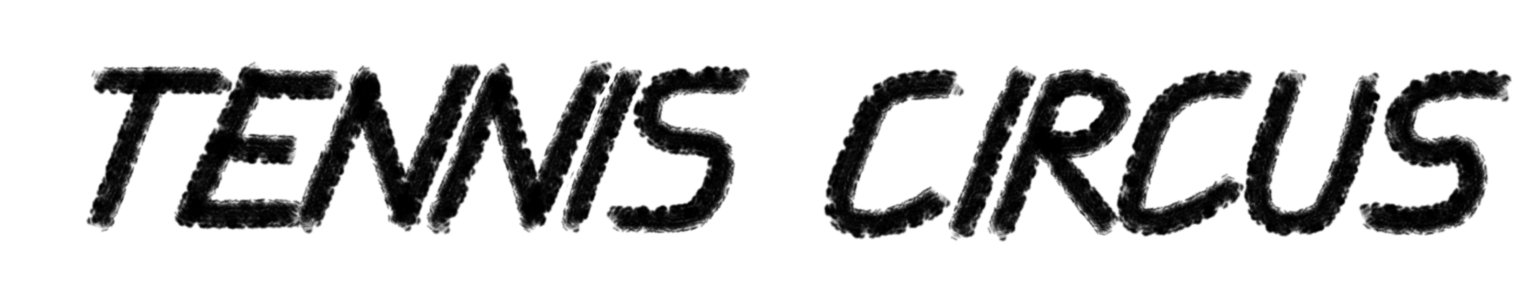









1 comment
L’ho letto volentieri, molto interessante