«Sul campo da tennis sei solo. Mi chiedono perché mi arrabbio così tanto: la solitudine in campo è una delle ragioni principali. Sentirmi solo, allo sbaraglio. A volte mi chiedo come tutto questo sia potuto accadere. Credo di essere stato spinto verso una carriera che non desideravo affatto. Ovviamente per me il tennis si è rivelato un’avventura incredibile, ma la verità è che non cercai questa carriera fino a quando non fu il tennis a cercare me. Molti atleti amano il loro sport con tutto il cuore. Non credo di aver mai provato un sentimento simile nei confronti del tennis. Non vedevo l’ora di giocare, ma la partita in se’ era una costante battaglia contro due avversari: l’altro giocatore e me stesso». John McEnroe, il braccio sinistro di Dio, il mancino dotato di un talento fuori quotazione che ha rivoluzionato, deliziato, sconvolto l’impettito mondo del tennis; il ribelle che non si è mai vergognato di urlare la propria rabbia in faccia agli arbitri, di disprezzare gli avversari, di insultare il pubblico; ma anche colui che ha portato la magia dentro un campo da tennis, l’uomo che più di ogni altro è stato associato al tennis, che era il tennis e che ha lasciato un vuoto incolmabile nel nome di quella geniale e irripetibile contraddizione quale era lui, nella sua essenza, nel suo essere John McEnroe.
John Patrick McEnroe Jr nasce il 16 febbraio del 1959 a Wiesbaden, nell’ex Germania Ovest, in una base militare statunitense dove all’epoca il padre prestava servizio come ufficiale della Air Force Statunitense. Figlio di John Joseph McEnroe, che una volta tornato in patria diventa associato in uno degli studi legali più prestigiosi di New York, e di Katherine Tresham, ex infermiera figlia di un vice sceriffo di Long Island; è dalla madre che John ‘eredita’ il carattere, quella “visione del mondo” che tanto lo influenzerà durante le tappe più importanti della sua vita, sia dentro che fuori dal campo da tennis. «La personalità di mio padre è intrisa di umorismo irlandese, infatti non c’è niente che ami di più che ritrovarsi con gli amici e farsi due birre. Mia madre invece è sempre stata una donna molto timida, eccessivamente esigente, diffidente anche verso le persone più miti. Per lei non esistono sfumature: le cose sono bianche o nere. A differenza di mio padre, io non saprei ripetere una barzelletta nemmeno fosse una questione di vita o di morte, ma in compenso tutte le ‘spigolosità di mia madre si sono impresse dentro di me».
John cresce a Douglaston, la tipica zona residenziale dell’area metropolitana di New York. Suo padre lo iscrive all’Accademia di Port Washington e inizia a giocare a tennis sotto alla guida di due maestri d’eccezione: Antonio Palafox, uno dei doppisti più forti negli anni 60’ ed Harry Hopman; l’uomo che aveva creato Rod Laver, Ken Rosewall, Lew Hoad e Roy Emerson. Proprio come il suo idolo, Rod Laver, il piccolo John usa la stessa impugnatura per ogni colpo: diritto, rovescio, servizio e volée. Non solo i suoi allenatori, anche un noto giornalista sportivo, tale George Lott, riconosce in lui le stigmate del campione, eppure a dodici anni il suo sogno è quello di diventare un giocatore professionista di basket. «Più le cose andavano bene, più diventava difficile anche solo pensare di abbandonare il tennis»; spiega con il senno di poi Mcenroe che ad appena sedici anni viene considerato uno dei migliori juniores degli Stati Uniti.
A diciassette anni, quando ancora l’US Open si giocava sulla terra verde, sfiora l’accesso al tabellone principale, o meglio, per alcuni minuti si qualifica proprio. Sul punteggio di 5-7 7-5 5-4, John va a servire per il match contro il numero 150 del mondo Zan Guerry ed un passante di rovescio sulla riga induce il giudice di sedia a proclamare: «game, set, match McEnroe». Guerry però non va a stringergli la mano, rimane a fissare il segno, per interminabili minuti richiamando l’attenzione dell’arbitro che, controllato il segno, conferma la sua decisione. John McEnroe invece di uscire dal campo, si intestardisce: vuole che il suo avversario si riconosca sconfitto e gli stringa la mano. Messo al corrente del parapiglia interviene il giudice arbitro, Anita Shukov, che fa ripetere il punto. McEnroe perde le staffe ed il match: da quel giorno arbitri e avversari saranno suoi nemici giurati.
La stella di John McEnroe si staglia in tutto il suo splendore nell’estate del 1977. Partito con 500$ sponsorizzati dalla USTA alla volta dell’Europa, vince il Roland Garros under 18 juniores e il doppio misto in coppia con Mary Carillo. A Wimbledon supera tre turni di qualificazioni e raggiunge le semifinali, prima di cedere a Jimmy Connors. «Prima del match mi avvicinai per salutarlo. Per me era già uno sforzo alzare la testa e guardarlo negli occhi ma lui non mi guardò nemmeno. Era come se si rifiutasse perfino di riconoscere che esistevo». Diventato professionista nel giugno del 1978, il mancino americano non riesce a confermare la strepitosa performance di Wimbledon ma scrive il suo nome nell’albo d’oro del Master dove sconfigge in finale Arthur Ashe. Da quel momento McEnroe è inarrestabile: nel 1979 vince dieci tornei, tra cui Dallas dove sconfigge in finale Bjorn Borg e si afferma per la prima volta in un torneo del Grande Slam, all’US Open, dove si sbarazza di Jimmy Connors, in semifinale e, nel match decisivo, di Vitas Gerulaitis.
L’anno seguente John McEnroe, che aveva già osato infrangere il religioso silenzio dell’All England Club con le sue intemperanze, entra nella storia di Wimbledon grazie alla finale, leggendaria, che gioca contro Bjorn Borg. Lo svedese è in vantaggio di due set a uno quando durante il tie-break si vede annullare cinque match point prima che l’americano, al sesto tentativo, porti l’incontro al quinto set. «Quando vinsi il tie-break per 18-16 sentivo di aver vinto il match. Pensai che Borg si sarebbe demotivato. Ma la forza che lo animava era al di là della mia immaginazione». Borg riesce a prevalere 8-6 al quinto vincendo il suo quinto Wimbledon consecutivo ma, poche settimane dopo, McEnroe difende il suo titolo all’US Open, sconfiggendo in finale proprio l’orso svedese per 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4. «A fine match ci stringemmo la mano e vidi che era distrutto. Era come se per la prima volta si fosse veramente sentito sopraffatto da me». La verità è che dopo quella sconfitta all’interno di quel meccanismo perfetto che anima Bjorn Borg avviene un cedimento, qualcosa si incrina, irrimediabilmente. Ma per attendere il passaggio di consegne definitivo bisogna attendere Wimbledon 1981
Quando un giudice di linea chiama fuori un servizio che solleva uno sbuffo di gesso, John McEnroe urla verso il giudice di sedia, lo scozzese Edward James, l’accusa che sarà destinata a diventare il titolo della sua autobiografia ufficiale: «Man, you cannot be serious!». È il primo turno della 95ª edizione del torneo di Wimbledon e “Super brat”, sempre durante il match disputato contro Tom Gullikson, arriva ad apostrofare la schiera arbitrale come «la feccia del mondo». I tabloid inglesi si scatenano ed un giornale riporta il parere di uno psicologo che definisce lo statunitense un “isterico estroverso”. Si scatena pure McEnroe che usurpa il regno di Bjorn Borg prima superandolo in finale a Wimbledon, poi scalzandolo dal primo posto del ranking mondiale. Il trionfo all’US Open, ottenuto proprio sconfiggendo in finale un Borg talmente furioso da disertare la premiazione, consacra John McEnroe come migliore giocatore del mondo. È l’inizio del suo regno, è la fine della rivalità con Borg, perché da quel giorno lo svedese inizia a maturare la decisione di abbandonare il tennis.
Il 1982 è un anno complesso per McEnroe, pur rimanendo in vetta al ranking per la maggior parte della stagione deve vedersela con un Jimmy Connors versione lusso e l’ascesa di un nuovo rivale, Ivan Lendl. Se il secondo sigillo a Wimbledon ottenuto nel 1983 prevalendo in finale sul modesto Chris Lewis non è stata una delle sue vittorie più memorabili, l’anno seguente McEnroe non solo trionfa lasciando per strada un solo set durante l’arco del torneo, giunto all’ultimo atto, umilia l’odiato Jimmy Connors battendolo 6-1 6-1 6-2. Una vittoria che, paradossalmente, non riuscirà mai a fare da contrappeso alla delusione rimediata appena un mese prima, al Roland Garros quando cede il passo ad Ivan Lendl dopo essersi trovato in vantaggio di due set a zero. Si tratta di una ferita mai sanata, che John McEnroe definisce: «La peggiore della mia vita, una sconfitta devastante. Quando ci ripenso non riesco ancora a dormire. Persino adesso è un’impresa commentare gli incontri dell’Open di Francia. Quando arrivo a Parigi per un paio di giorni ho la nausea, perché sono lì e torno con il pensiero a quella partita. A ciò che buttai via quel giorno, a come la mia vita sarebbe stata diversa se avessi vinto». Il 1984 di John McEnroe rimane comunque la sua stagione migliore: dopo Wimbledon vince il suo quarto US Open ed il suo terzo Master chiudendo l’annata con un bilancio di 82 vittorie e 3 sconfitte.
Nel 1985 McEnroe raggiunge dieci finali in tornei ATP vincendone otto, ma negli Slam non riesce a trovare il suo tennis migliore. All’Australian Open perde ai quarti di finale in cinque set da Slobodan Zivonjinovic, al Roland Garros si arrende in semifinale a Mats Wilander ed a Wimbledon viene sovrastato 6-2 6-2 6-4 da Kevin Curren. L’US Open rappresenta per il John McEnroe un’occasione di riscatto. «In finale contro Lendl andai in vantaggio 5-2, poi all‘improvviso, dopo il cambio campo mi alzai, raggiunsi la mia parte del campo e avvertii una strana sensazione. Era come se il mio corpo fosse rimasto a sedere. Mi ero spento». Quel match rappresenta una svolta decisiva, sia per la carriera di John McEnroe che per quella di Ivan Lendl. Se nel 1981 le sconfitte che John McEnroe infligge a Borg prima a Wimbledon poi all’US Open provocano nella mente dello svedese uno squarcio devastante; la rimonta di Ivan Lendl al Roland Garros nel 1984 e quel 7-6 6-3 6-4 scandito sempre dal ceco all’US Open 1985, fanno sentire il geniale mancino «tagliato fuori. Mi aveva scalzato dalla vetta, il numero uno era lui».
Nel 1986 John McEnroe si prende una sorta di anno sabbatico, si sposa con l’attrice Tatum O’Neil, diventa padre, nel 1987 ritorna senza però mai essere veramente competitivo, vuoi perché la schiena gli fa spesso male, vuoi perché il tennis ha preso irrimediabilmente un’altra direzione e lui non è più disposto ad adeguarsi a quella nuova dimensione così fisica, robotica. «Non è stato solo il talento, è stata anche la mia determinazione a portarmi dove ero arrivato. Poi quella ferocia è svanita». Nel 1989 raggiunge la semifinale a Wimbledon, dove perde contro Stefan Edberg, l’anno dopo è semifinalista agli Us Open e in questo caso a superarlo è il futuro Re degli anni 90’, Pete Sampras. L’ultimo acuto avviene a Wimbledon, nel 1992, quando si issa fino alla semifinale in singolare, e insieme a Michael Stich vince il torneo in doppio.
77 titoli ATP tra cui 7 prove del Grande Slam e tre Master. In doppio di successi ne ha totalizzati 71: dieci di essi sono Slam; nove nella categoria maschile ed uno nel misto. Addirittura sette sono i trionfi al Master, tutti consecutivi e tutti insieme a Peter Fleming, come del resto la maggior parte dei titoli di specialità. «Fin dall’infanzia con Peter Fleming si instaurò un legame molto forte. Siamo stati compagni di doppio per più di dieci anni, ci completavamo a vicenda», ricorda John McEnroe nella sua biografia. Accadde però un episodio che rovina tutto. Dopo aver sconfitto Yannick Noah ed Henri Leconte nella finale di Coppa Davis nel 1982, un giornalista chiese a Peter Fleming quale fosse la più grande coppia nella storia del doppio e lui rispose: «John McEnroe e un tennista qualsiasi». Forse Peter Fleming ha sempre avuto la sensazione di vivere nell’ombra del leggendario compagno, o forse come ammette John: «Non ho mai potuto sopportare di cedere il passo a qualcuno di cui ero amico e nonostante Peter non sia mai stato un giocatore di alta classifica, lui possedeva doti che io non avevo, come portare empaticamente il pubblico dalla sua parte». Piccole gelosie, tanti dissapori e altrettante incomprensioni finirono con il separare quello che è stato probabilmente il doppio più forte di sempre.
Dopo il divorzio con Tatum O’Neil, l’ex ‘moccioso’ del tennis vive con la sua seconda moglie, Patty Smyth e con sei figli, tre avuti dal primo matrimonio, due dalla seconda consorte, e uno che Patty ha avuto dal precedente marito. A volte capita che torni ad essere ‘the genius’ e prenda la racchetta in mano per partecipare a qualche torneo senior o esibizione. Ora, ufficialmente, è però un commentatore sportivo per la BBC che si diletta a suonare la chitarra ben figurando quando viene invitato a salire sul palco durante concerti, trasmissioni o eventi benefici. Lui e la musica sono uniti da un legame di lunga data e forse non è un caso che Chrissie Hyde, la cantante dei Pretenders, abbia inserito in un suo noto brano, «Pack it up» la famosissima frase urlata da John McEnroe allo scandalizzato pubblico londinese: «You are the pits of the world!»; siete la feccia del mondo. Era il 1981, ma John McEnroe immortale lo era già.
Fa un certo effetto leggere una considerazione riportata da John McEnroe nella sua biografia: «Quando raggiungi la vetta da giovanissimo poi una parte di te cerca costantemente di rivivere quelle emozioni travolgenti. Questo è il motivo per cui molti atleti finiscono male. Non riescono più a trovare quell’euforia assoluta ed avvertono un terribile vuoto. La mia vita al contrario, è piena di cose positive, lo è sempre di più, ma per quanto sia fantastica, a volte è difficile dimenticare quelle vittorie esaltanti. In quei momenti devo ricordare a me stesso che non avevo nessuno con cui condividerle. E ripenso a quanto fredda e solitaria fosse la vetta della montagna».
Dice sul serio John McEnroe. Così come dicono sul serio i reduci di quel mitico periodo, quello tra la fine degli anni 70 e il tramonto degli anni 80’, quando ripensano a quelle sfide crudeli, estenuanti, a quegli odi viscerali, esagerati, forse folli. Come possono i tennisti moderni, così ‘politicamente corretti’, regalare le scariche di adrenalina sperimentate con John McEnroe; con Bjorn Borg, lo svedese di ghiaccio; con Jimmy Connors, l’antipatico che come un invasato fomentava le folle; con Ivan Lendl, il profugo che ha osato usurpare il loro regno? E poi, via, via fino ad arrivare a Wilander, a Becker ad Edberg… Certo ora c’è Roger Federer, l’uomo dei record, Mr perfect; c’è Rafael Nadal, il Re della terra che ha superato persino Borg a Parigi; c’è Novak Djokovic, la macchina perfetta. Eppure… eppure se parliamo con i reduci di quegli anni magici, ci diranno non è la stessa cosa.
Ho un ricordo appannato dell’US Open 1992. Non tanto riguardo al torneo: ricordo la vittoria di Ivan Lendl al quinto set contro Boris Becker e la sua successiva sconfitta per 7-6 al quinto contro Stefan Edberg; che poi sarebbe prevalso in finale su Pete Sampras. Ho ben presente pure che John McEnroe perse contro Jim Courier, agli ottavi di finale. Il ricordo appannato riguarda una frase che disse Gianni Clerici. Ero una ragazzina, tifavo per Ivan Lendl e John McEnroe non è che mi stesse tanto simpatico. Ma Gianni Clerici disse qualcosa tipo «ho sempre saputo che il giorno in cui John McEnroe avrebbe giocato la sua ultima partita un pezzo del mio cuore si sarebbe spento per sempre». Qualcosa di simile. Non so perché non riesco a ricordare precisamente cosa disse Clerici. Ricordo però che lo disse con un tono di voce che mi commosse. Il suo dolore era sincero. Il silenzio che seguì, fu qualcosa di talmente profondo da indurmi ad afferrare il telecomando e ad alzare il volume. Ma non era un problema dell’audio. Gianni Clerici rimase in silenzio e fu come se sopra New York fosse calato un vuoto incolmabile. Sono passati più di venti anni. John McEnroe è un uomo di quasi sessant’anni, con i capelli brizzolati. Quel vuoto incolmabile però, resiste ancora.

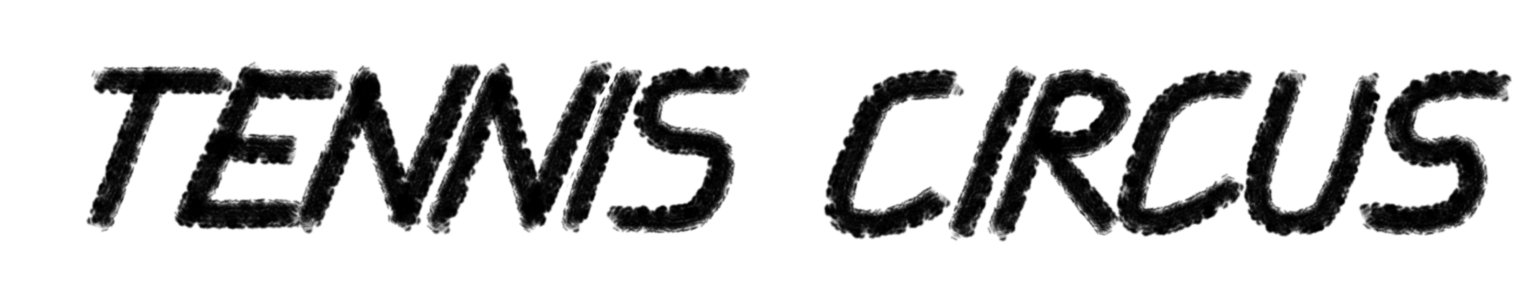











2 comments
Davvero il braccio sinistro di Dio…
The Genius….