Ci sono fiori che non appassiscono mai, altri che sbocciano tardi, altri ancora che durano un alito di vento. Nel deserto, quantunque macchiato da verdeggianti palmeti come quello californiano di Indian Wells, resistono invece solo le rose di pietra. Dure. Ancestrali. Con i petali modellati e irruviditi dal vento. Asciutte. Come Roger Federer. E come la sua connazionale Martina Hingis. Due immortali della racchetta. Gli ultimi di una generazione ormai finita negli archivi polverosi di uno sport, il tennis, che necessita ora più che mai di esperienza e maturità per competere – e, soprattutto, vincere – agli altissimi livelli.
Altissimo, quasi irraggiungibile, era certamente il livello iniziale del singolare maschile del primo ATP Masters 1000 della stagione in corso. Un torneo, quello dei pozzi indiani, come al solito organizzato alla perfezione in una location naturalmente suggestiva e dedita al tennis a 360° per quasi due settimane. Con eccellenti risultati. Un torneo in cui la nomina di Tommy Haas nei panni di direttore, in luogo di quel Ray Moore che proprio un anno fa si lasciò scappare una considerazione politicamente scorretta (quantunque largamente condivisa nei pensieri di tifosi e addetti ai lavori) nei confronti del circuito femminile, è coincisa con un sorteggio a dir poco bizzarro che ha collocato il n°1 Andy Murray nel deserto (di favoriti) e tutti gli altri a scannarsi tra loro nell’oasi della parte bassa. Conferme e smentite, ecco ciò che ci si attendeva dai campi del Tennis Garden. E hanno prevalso le prime. Da dove vogliamo iniziare? Dall’insostenibile leggerezza dell’essere numeri 1 di Andy Murray? O dall’insopportabile peso di non esserlo più di Novak Djokovic? O ancora dall’avvilente evidenza che la velenosa e mortifera mano sinistra di Rafael Nadal non lascia più alcun segno sul rovescio leggiadro e spensierato di Roger Federer? O infine che la NextGen è bella che nutrita ma deve ancora mettere muscoli e carne attorno a scheletri già più che promettenti.

Andiamo con ordine, dunque, e partiamo con il debutto choc di Andy Murray. “Qui non mi esprimo mai al meglio” avrebbe confessato lo scozzese dopo la sconfitta al debutto (secondo turno dopo il bye) contro l’incostante canadese Vasek Pospisil. In effetti torto non ha, se si considera che in 12 partecipazioni ha raggiunto solo una volta la finale e in quell’occasione (era il 2009) raggranellò appena tre giochi (6-1, 6-2) con Nadal. Questo però non giustifica appieno la débâcle rimediata al cospetto del n°129 del ranking ed entrato in tabellone dalle qualificazioni, un 6-4, 7-6 che ha vanificato almeno in parte la vittoria di Dubai e ripropone i dubbi sulla legittimità della sua leadership. Poi, alla fine, si è venuto a sapere che il britannico salterà Miami per un problema al gomito destro, evidentemente un malanno contagioso visto che pure Djokovic darà forfait per il medesimo motivo.
Ecco, Djokovic. La nebbia attorno al tri-campione in carica – che non perdeva dalla semifinale del 2013 contro Del Potro – non si è affatto diradata. Tutt’altro. Ci può stare, eccome se ci può stare di perdere dal più cristallino tra i nuovi talenti che frequentano il circuito, quel Nick Kyrgios che, come ha evidenziato Federer, “non si limita ad affrontare i migliori della classe, li batte” e potrebbe ben presto insediarsi nella zona nobile della classifica. L’australiano, poi costretto a rinunciare alla sfida con Roger per via di un problema intestinale, aveva battuto Nole anche ad Acapulco dopo che il serbo si era imposto a Del Potro (come qui) e il risultato, di questi tempi, non fa gridare allo scandalo. Però Djokovic non è più lui, ha gli occhi spenti e la cenere al posto delle braci, gli manca sempre una frazione di secondo nelle gambe e un grammo di grinta nella testa. Darlo per finito, questo mai, ma certo la risalita pare ardua e perigliosa. Anche perché il cammino proseguirà con i 1000 punti in meno di Miami, dove pure era campione uscente. Fin qui, dunque, conferme (di crisi) da parte dei primi due del lotto. Una doppia smentita invece è arrivata da Stan Wawrinka. La prima, positiva per lui, è che finalmente ha giocato bene anche sul cemento americano raggiungendo per la prima volta in carriera la finale in un 1000 sul duro. La seconda è che, di solito, quando arriva in fondo non ce n’è per nessuno e invece stavolta ha dovuto rassegnarsi ad alzare il riconoscimento riservato al finalista. Questo perché, ed eccoci al momento in cui conferme e smentite vanno di pari passo, dall’altra parte della rete c’era l’uomo per cui qualsiasi dizionario di qualsiasi lingua ha terminato gli aggettivi.
Chi voleva che Roger Federer si ritirasse in bellezza con la cintura addosso dopo la clamorosa affermazione di Melbourne, è stato sonoramente smentito. La serataccia di Dubai contro Donskoy, carburante per alimentare la convinzione di cui sopra – ovvero che non aveva senso sporcare l’impresa con prestazioni opache quale quella nell’emirato -, aveva messo in dubbio la voglia dello svizzero di sbattersi ancora per qualcosa che non valesse davvero la pena. Ma, onestamente, cosa può veramente valere la pena per un tipo del genere? Cosa lo può veramente stimolare? Niente, tranne il fatto di “sentirsi bene e stare sul campo per divertirsi”. Si sono divertiti un po’ meno i suoi avversari, incapaci di rubargli il servizio per quasi tutto l’arco del torneo (un solo break subìto, da Wawrinka nel secondo set della finale) e tutti rispediti al mittente senza set all’attivo. Sì, avete letto bene: cinque vittorie per 2-0 e la sensazione che questo Federer sprizzi salute da ogni poro. Onestà impone di accennare anche alla buona sorte di non aver incrociato la racchetta con Kyrgios, privando il pubblico californiano e televisivo di una sfida generazionale affascinante quanto insidiosa per Roger, ma non c’era traccia di borotalco nel tabellone proibitivo dell’elvetico, iniziato in discesa con il francese Robert e proseguito contro sole teste di serie: Johnson (24), Nadal (5), Sock (17) e Wawrinka (3). Su un campo decisamente più lento di quello australiano, Federer ha menato la danza anche quando il programma l’ha costretto a scendere in campo con temperature rilevanti, a dimostrazione che i sei mesi di inattività hanno restituito al circuito un atleta integro nel fisico e libero nella testa, oltre che magnificamente seguito all’angolo dalla famiglia (oggi allargata a Ljubo, secondo alcuni il vero artefice di questa resurrezione). Come dicevamo sopra, questo era il torneo in cui Federer doveva confermarsi e smentire al contempo chi pensava che l’Australian Open fosse stato un episodio irripetibile. Missione compiuta anche nella modalità di esecuzione, con il 6-2, 6-3 inflitto a Nadal quale ciliegina sulla torta in cui ha spento la 90esima candelina, 25esima in un 1000. “Questa vittoria, come quella australiana, non rientrava nei programmi” ha detto Roger, tra il serio e il faceto. “Volevo essere almeno tra i primi 8 dopo Wimbledon e questi risultati sorprendono me prima ancora di tutti gli altri”. Lo spagnolo ha deluso ma siamo più propensi a credergli quando ha dichiarato che “non era la mia giornata” dopo la sconfitta con Federer di quanto invece pensiamo che il suo cammino sul viale del tramonto sia già a buon punto. Le certezze che aveva contro lo svizzero si sono incrinate non poco in questo 2017 ma l’atteggiamento complessivo di Rafa è quello giusto e già dalla Florida potrebbero arrivare per lui buone nuove. Se anche il dritto non è più quello del tempo che fu, Nadal adesso pare aver accantonato i suoi demoni e sulla terra rossa, se non prima, sarà di nuovo lui l’uomo da battere.
Infine, gli altri. Bene, benissimo anzi, Sock e Thiem. Lo statunitense ha battuto, tra gli altri, Dimitrov (il bulgaro sta rifiatando ma tornerà) e Nishikori (ennesima occasione persa dal giapponese) e si è arreso solo a Federer; l’austriaco invece ha battuto Mischa Zverev e Monfils e perso solo 7-6 al terzo con Wawrinka, sfiorando la possibilità di andare in finale perché da quella parte l’altro semifinalista era Carreño Busta, lesto ad approfittare di un tabellone autostradale ulteriormente accomodato dalla prematura uscita di Murray. Bene anche Fognini (ha battuto Tsonga) e Cuevas (ha battuto Fognini che aveva battuto Tsonga e per di più non è proprio un tipo da cemento), male invece Alexander Zverev (domato da Kyrgios nell’anticipazione del futuro) e Querrey, che si è fatto battere dall’ex promessa statunitense Donald Young.
Inizieremo a parlare del torneo femminile dal doppio. Scelta inusuale, certo, ma suggestiva se non altro perché ha visto trionfare (il primo titolo del 2017) un’altra leggenda vivente, ovvero Martina Hingis. La svizzera ha collezionato il 56° titolo in doppio e lo ha fatto con la 17esima compagna diversa. Stavolta ad avere l’onore di affiancare Martina è stata la cinese di Taipei Yung-Jan Chan e la coppia, designata con la sesta testa di serie, ha battuto in finale quella composta da Hradecka/Siniakova anche se l’exploit vero e proprio era giunto in semifinale contro le n°1 Mattek-Sands/Safarova. Detto questo, veniamo al singolare e speriamo di non fare la fine di Ray Moore. Sì perché non si può ignorare come, in questo preciso momento storico, il circuito WTA non stia attraversando il suo miglior momento. Prima ancora di iniziare a giocare, il forfait di Serena Williams ha tolto dal campo la vincitrice degli Australian Open e ricollocato sulla testa di Angelique Kerber la corona mondiale. Assente pure la campionessa in carica Victoria Azarenka, in procinto di rientrare dopo la maternità, il torneo era alla disperata ricerca di una erede legittima dell’ucraina e invece ha trovato una trentenne russa fin qui più gratificata dal doppio. Elena Vesnina, classe 1986, aveva vinto in carriera due titoli (Hobart e Eastbourne, entrambi nel 2013) e in dieci anni era passata dal n°111 del 2005 al n°111 del 2015 passando però per un best-ranking di fine stagione da n°24 nel 2009 e 25 nel 2013. Insomma, tanto per prendere spunto dalla nazione che le ha dato i natali, montagne russe per Elena che invece a Indian Wells non ha tremato e si è portata a casa la vittoria più bella della sua vita sportiva. La defezione di Serena a tabellone completato ha costretto gli organizzatori a rivedere la collocazione delle teste di serie e il posto della (ex) numero 1 è stato preso da Karolina Pliskova. La ceca sembrava in grado di sostituire la Williams anche nella graduatoria (spesso aleatoria in campo femminile) dei favori del pronostico ma è stata fermata in semifinale dalla veterana Kuznetsova in due tie-break, gli stessi con i quali Karolina aveva liquidato nei quarti una Muguruza finalmente convincente e brava ad interrompere la striscia vincente di Elina Svitolina. Mentre nella parte alta le sorprese erano relative (Pavlyuchenkova vincitrice sulla Cibulkova, la francese Garcia sulla Konta, un’altra che sta rifiatando), in basso le emozioni arrivavano soprattutto da Venus Williams (che annullava tre match-point alla Jankovic), nei quarti a spese dell’ennesima resuscitata di questi tempi (la cinese Peng Shuai), e dalla Kerber, quasi eliminata dalla Parmentier prima di farsi prendere a male palle dalla Vesnina (doppio 6-3). Sulla scia dell’entusiasmo, Elena ha regolato anche Venus (6-3 al terzo) e in semifinale ha trovato “Kiki” Mladenovic che, dopo aver divorziato da una Caroline (Garcia, in doppio) ne ha regolato un’altra (Wozniacki, a cui manca sempre uno per fare trentuno) nei quarti prima di offrirsi sull’altare dell’entusiasmo della futura campionessa Vesnina.

La finale è stata quantomeno emozionante, nonostante la calura e l’attesa sugli spalti per la sfida Federer-Wawrinka. Le due russe giocano un tennis simile anche se Sveta fa più male col dritto e la connazionale si fa preferire di rovescio. Kuznetsova ha avuto a lungo le redini del match tra le mani ma non è mai riuscita, dal secondo set in poi, a distanziare l’amica-rivale di più di un break. Tuttavia, essere avanti 4-1 nella seconda frazione e 4-2 e servizio nella terza e non riuscire a capitalizzare il vantaggio è una colpa grave per Sveta, che puntava finalmente a vincere questo torneo dopo aver perso le finali del 2007 e 2008. I problemi fisici successivi agli Australian Open (e che le avevano fatto saltare le tappe di Doha e Dubai) sembrano però passati per la Kuznetsova, che a Miami difende la finale conquistata lo scorso anno. Per Elena Vesnina invece il risveglio è con un trofeo di cristallo tra le mani, il best-ranking in classifica (13) e tanta voglia di tornare a stupire in Florida. Staremo a vedere.
Tommaso Borgatti
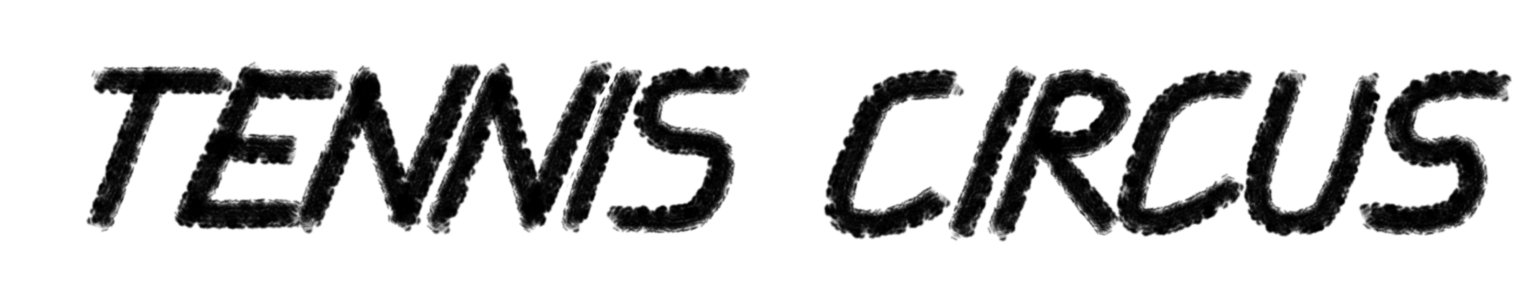










1 comment
roger ha vinto ,ma vorrei vederlo con unadal non con la febbre e ocnil nadal come agli au open ,e al 5 set era 3 a 0 e roger ha ivnto anche perche nadal aveva 36 ore di riposo in meno ,a dubai a giocato benissimo roger e a perso ,iw a vinto ma vince con un nadal febbroso e giocava cortissimo e si vedeva che era febbre ,poi roger approffitta di questa poco froma di nnole e murray ,io penso che un nadal al 100% si mangia roger i un boccone ,a indian wells chi dice che roger a battuto un nadal al top e non con febbre è perche sa che roger puo solo vincere con un nadalk cosi,io penso che a miami sia un altra cosa ,con u nadal non piu febbre e con giocatori che hanno trovato la forsza e condizione ,poi roger con i nuovi kyrghios non vincera,bravo ad approffitarne come fece nadal s madrid 2014 con nischikory ,ma poi.si è visto ,ROGER CON UN NADLA IN FORMA E CON RIPOSO ALLA PARI AGLI AU OPEN AL 5 SET NON AVREBBE FATTO DOPO IL 3 A 0 8 DOPPI FALLI E 15 ERRORI NON FORZATI