«Un tempo ero troppo emotivo perché avvertivo le forti aspettative che c’erano su di me. Quando hai talento te ne accorgi, ma quando tutti ti ripetono che puoi diventare il più forte, che puoi vincere questo e quello, che fai apparire facili le cose più difficili, che ridicolizzi l’avversario con smorzate e lob, che sei l’erede di Sampras, allora tutte quelle parole fanno il giro completo e ti tornano in faccia, come un boomerang». Dietro a queste parole emerge tutta la responsabilità di un ragazzo di appena ventidue anni consapevole che il mondo del tennis ha caricato sulle sue spalle tutte le sue aspettative, tutte le sue frustrazioni, tutti i suoi sogni. Era il 2003 e certamente Roger Federer non poteva immaginare che avrebbe finito con il riscrivere la storia di questo sport. Non credeva che intorno a lui si sarebbero create aspettative così enormi da dover accogliere ogni suoi trionfo come doveroso e ogni sua sconfitta come un oltraggio inflitto non contro di se’, quasi contro al tennis stesso. Quel ragazzo ha vinto molto, anzi tutto, per poi rivincerlo. In lui coesiste la via della grazia e la via della natura: il suo talento lo ha reso un semidio, la sua ambizione lo ha trasformato in un cannibale.
Eppure il mondo del tennis, degli appassionati, ha continuato a pretendere da lui, non lo ha solo osannato, lo ha anche denigrato dandolo “per finito” una prima volta dopo la sconfitta subita in finale a Wimbledon 2008 per mano di Rafael Nadal, dopo una battaglia lunga 4 ore e 48 minuti terminata con il punteggio di 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7; una seconda al termine della stagione 2011, quando chiuse l’annata senza essere riuscito a vincere uno slam; una terza a conclusione di un 2013 a dir poco disastroso, persino una quarta, quando il 26 luglio del 2016 annuncia che lì sarebbe finita la sua stagione in quanto, dopo l’intervento subito al ginocchio sinistro avvenuto a febbraio, sentiva il bisogno di prendersi un lungo periodo di riposo. Per quattro volte lo spettro del declino ha oscurato Roger Federer. Per quattro volte buona parte degli addetti ai lavori e non solo, hanno abbassato la puntina del giradischi affinché iniziassero a risuonare le lugubri note del Requiem. Roger Federer però, è sempre risorto. Nel 2009 mettendo finalmente le mani sul Roland Garros e imponendosi a Wimbledon, nel 2012 tornando a dettar legge nello slam londinese e riprendendosi il trono, nel 2014 arricchendo nell’arco di due annate il suo palmares di altri 11 titoli, e nel 2017 toccando quota 19 titoli del Grande Slam dopo i trionfi all’Australian Open e Wimbledon – dove ha vestito i panni di primo nella storia a incidere l’ottavo sigillo – ma non solo, perché nell’arco di questi dodici mesi ha affondato l’uno-due a Indian Wells-Miami, si è incoronato Kaiser per la nona volta a Halle, ha messo tutti in riga a Shanghai ed è stato per l’ottava volta assoluta profeta in patria nel torneo di casa.
E così, mentre i cacciatori di record hanno speso ore alla ricerca di nuovi e sempre più clamorosi traguardi tagliati o da tagliare, mentre altri scrivono libri, saggi, filosofeggiando intorno alla sua carismatica figura; Roger Federer si è rivelato per quello che è: un cannibale della racchetta che non sa cosa farsene delle metafore mentre mai pago, mai veramente in pace, prosegue la sua corsa in solitaria tra le leggende di questo sport, spinto dalla consapevolezza di essere stato e di essere spesso l’artefice delle sue vittorie quanto delle sue sconfitte; e solo allora, quando sentirà che sono gli avversari a batterlo e non lui a perdere, appenderà la racchetta al chiodo.
Il bambino destinato a diventare una sorta di creatura mitologica ha visto la luce a Basilea, l’8 agosto del 1981. Suo padre, Robert Federer, è svizzero di Berneck, la madre Lynette Durand è sudafricana. Cresciuto a Münchenstein, nel confine tra Germania e Francia, Roger inizia a giocare a tennis a sei anni, alternando il nobil gioco al calcio, finché dodicenne decide di dedicarsi esclusivamente alla racchetta. Le tappe della sua prodigiosa crescita lo vogliono campione svizzero assoluto a quattordici anni, per poi diventare nel 1998 campioncino a Wimbledon juniores, anno in cui trionfa pure all’Orange Bowl, diventando così n.1 del mondo ITF. Se la prima finale ATP risale a Marsiglia nel 2000, dove a sconfiggerlo è il connazionale Marc Rosset, il primo titolo Federer lo stringe in pugno il 29 gennaio del 2001 sul sintetico indoor di Milano. Seppure Linette avrebbe affermato, molti anni dopo lo sfortunato agosto del 2002, che presenziare al funerale del coach Peter Carter, fu «un’esperienza che avrebbe reso Roger più forte», già da Wimbledon 2001 il mondo del tennis aveva potuto appurare quanto potenziale covasse nel divin figliolo.
Aver posto fine al regno di Pete Sampras sul centrale dell’All England Club rappresenta forse il primo passo di un’epopea, divenuta ufficialmente Era Federer quando il 3 luglio del 2003 lo svizzero batte, sul Centre Court, Mark Philippouissis stringendo così in pugno il primo di 19 titoli del Grande Slam. In mezzo è accaduto ovviamente di tutto: dal mito di una presunta imbattibilità scalfita dalle quasi sistematiche capitolazioni contro Rafael Nadal, all’ossessione di vincere il Roland Garros, fobia domata, va ammesso, con la complicità di Robin Soderling, dai 5 US Open consecutivi all’essersi proclamato per sei volte maestro alle ATP Finals, agli attuali 95 titoli ATP che luccicano in bacheca, concedendo allo stesso tempo uno spazio degno di nota alla beneficenza elargita tramite la sua Fondazione, celebrando ampiamente la complicità con la moglie Mirka Vavrinec, madre di due coppie di gemellini e che a detta del prestigioso consorte è il segreto del suo successo, ma ancor più meritandosi il rispetto di tutto il pianeta, colleghi compresi, perché come sostiene John Isner «se il tennis fosse una religione, Roger Federer sarebbe il suo Dio». Come se non bastassero i numeri per eleggere Roger Federer il numero uno dei numeri uno.
Il miglior tennista di sempre? Forse sì, forse no. Si cade nel solito, tedioso, discorso: è impossibile paragonare epoche diverse. Ogni tanto però qualcuno compie un piccolo sforzo, stimola un po’ la fantasia e cerca di confrontarle queste epoche, cerca di contrapporli questi campioni divisi da decenni, cerca di immaginare le sfide impossibili tra Federer e i vari Laver, Rosewall, Borg, Connors, Lendl, McEnroe, Becker, Edberg. Immancabilmente ne esce un quadro un po’ confuso, a tratti rozzo: bisogna far impugnare a Roger la preistorica Wilson T2000 di Connors, oppure all’americano diamo in mano una recente Wilson Pro Staff 97? Insomma, tanto rumore per nulla. È indiscutibile che il tennis maschile abbia conosciuto epoche leggendarie, forse culminate negli anni 80’ e tutto sommato vanno accolte con serenità le opinioni di chi sostiene che un Federer (ma pure un Nadal o un Djokovic) lanciato nella mischia di quel periodo difficilmente avrebbe toccato le due cifre quanto a conteggio slam.
E a proposito di cifre questi 19 titoli slam racchiusi nei 95 complessivi comprendono 5 Australian Open (2004 , 2006, 2007, 2010, 2017), 1 Roland Garros (2009), 8 Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), 5 U.S Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), 6 Master (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) e 27 Master 1000; tra cui 5 Indian Wells, 3 Miami Open, 2 Rogers Cup, 2 Mutua Madrid Open, 3 Shanghai Rolex Master e 7 Western & Souther di Cincinnati. Ci sono poi le settimane trascorse sul primo gradino del ranking: 302. Insomma, è innegabile che Roger Federer sia uno dei maggiori esponenti non solo del tennis, ma dello sport in generale. E questa risonanza non è dovuta semplicemente ai numeri ma anche al suo tennis elegante eppure al tempo stesso aggressivo, virtuoso e concreto insieme. Un tennis che evoca la congiunzione perfetta tra il passato, il presente e il futuro.
Di certo la longevità tennistica di Roger Federer è un qualcosa che va al di là dell’indiscutibile talento il quale ha finito (troppo) spesso con l’oscurare altre due doti fondamentali del fenomeno elvetico: essere un atleta eccelso e un professionista impeccabile. Attitudini che il suo storico preparatore atletico, Pierre Paganini, racchiude in poche semplici frasi: «Spesso la gente non vuole capire che avere più talento può significare persino lavorare di più. Per essere competitivo a certi livelli, alla sua età, se vuole fare la differenza, è questo che Roger deve fare. E sta facendo. Il suo fisico glielo permette e lui, in ogni seduta, è motivato come se dovesse ancora costruirsi una carriera». Ma c’é dell’altro. A detta di Paganini «se si analizza la sua carriera è possibile rendersi conto di come sia sempre riuscito a trovare soluzioni per gestire le situazioni avverse».
Una dichiarazione che andrebbe a cozzare con le imputazioni mosse nel luglio 2010 dalla giornalista canadese Stephanie Myles e responsabili, a sua opinione, della sconfitta subita dallo svizzero contro Tomas Beredych ai quarti di Wimbledon: essersi barricato dietro ai suoi trionfi impuntandosi a non cambiare niente, dalla racchetta al gioco, auto-compiacendosi della e nella bellezza che era capace di esprimere tramite i suoi colpi, visivamente grandiosi, ma ormai inefficaci al cospetto di un tennis più fisico e maschio.
Ebbene, ripercorrendo l’iter dei coach di Federer si passa dallo sfortunato Peter Carter a Peter Lundgren. Se nel 2004 nel box di Roger fu anarchia totale, dal 2005 al maggio 2007 è stato allenato da Tony Roche a cui fu fatale lo stop contro Volandri a Roma. L’entrata in pianta stabile di Severin Luthi, avvenuta nel 2008, prevederà una serie di doppie collaborazioni: per una manciata di annate con José Higueras, dal 2010 al 2012 con Paul Annacone, nel 2013 con Stefan Edberg e infine dal 2016 con Ivan Ljubicic.
Oggettivamente il ristagno suggerito da Stephanie Myles è un po’ aleggiato nell’arco di alcune stagioni dove un Federer incaponito sulla riga di fondo aveva scoperto il fianco sinistro che trasfiguratosi in un rovescio eseguito quasi esclusivamente in slice era diventato facile preda di tanti avversari. Un appunto a cui Federer avrebbe risposto con il cambio di telaio avvenuto nel 2013, anno in cui la presenza di Edberg l’ha spinto a rivalutare tattiche più aggressive, fino alla svolta attuata durante i sei mesi di pausa dal circuito nel 2016, necessari per presentarsi in Australia con un rovescio in top in grado di garantire al suo gioco una maggior solidità e micidiali accelerazioni. Una chiave di volta che ha consentito a Federer di trovare le contromisure alla diagonale mancina di Nadal e, in linea più generale, di evitare l’apertura di spazi su cui una serie di avversari degni potevano far leva a forza di incessanti martellamenti sul vecchio slice. Ma soprattutto una dimostrazione di umiltà nel rimettersi in gioco che va di pari passo con l’ambizione che muove un campione eccezionale, prima ancora che nel braccio, nella mente.
«Siete Norma Desmond, la famosa attrice del muto. Eravate grande!» – «Io sono ancora grande, è il cinema che è diventato piccolo!». Questo celebre quanto amaro scambio di battute proveniente da Sunset Boulevard, in Italia noto come Viale del tramonto, denuncia l’effimero mondo di Hollywood, pronto a calpestare tutto ciò che è vecchio, passato, e Norma Desmond incarna il fantasma di una ex diva, considerata un tempo una Dea poi caduta nel dimenticatoio. Dal cinema al tennis il passo è breve e, seppure i toni siano meno drastici, prima o poi le vecchie glorie dovranno piegarsi al cospetto del nuovo che avanza. Ogni generazione di campioni è destinata al tramonto per essere sottoposta a letture e riletture di frequente superficiali, indegne. È il nuovo a scendere in campo, è il nuovo ad essere più veloce, più potente, più preparato, meglio vestito, meglio tutto. È una ruota che gira. È accaduto a Rod Laver. È capitato a Bjorn Borg. È valso per John McEnroe. Varrà pure per Roger Federer? Al solo pensiero vien meno il respiro. Come è possibile che un giocatore tanto sublime possa disperdersi nelle tenebre per essere rispolverato solo quando verranno confrontati i suoi record con i successi del campione di turno, magari del 2050?
In una scena di Sunset Boulevard, Norma Desmond offre al suo giovane ospite una proiezione privata ed egli rimane abbagliato dalla potenza del cinema muto, dalla forza espressiva dei volti, dei gesti, di tutta la grazia ma anche la potenza visiva andata persa con l’avvento del sonoro. «Non avevamo bisogno di parole, avevamo dei volti!»; spiega l’ex Dea. La grandezza e l’orrore del tempo che tutto macina è proprio lì, nel bisogno di cambiamenti, nelle epoche destinate a scontrarsi, nell’esito che sembra inevitabilmente destinato a premiare le più recenti.
Se nell’ultima scena di Sunset Boulevard Norma Desmond appare estraniata dalla realtà che la circonda, Roger Federer si appresta ad affrontare gli ultimi anni della sua carriera con la mente lucida e ancora dei traguardi concreti da tagliare; in quanto si definisce «ancora motivato e affamato»; forse per battere l’ennesimo record, per alimentare la propria leggenda, forse per rendere ancora più potente la metafora dell’eletto che continua a far valere il suo stato divino, negando a se’ stesso la verità, che è già giunto in cima alla montagna e ormai non esiste nulla di più alto. O forse, chissà, per passione; quel sentimento impetuoso che impedisce il controllo della ragione mescolando gioie, dolori, speranze, e ricordi. Per scongiurare quel momento. Per alimentare l’illusione che tutto passa, tutto tranne lui. Perché Roger Federer non passerà mai.
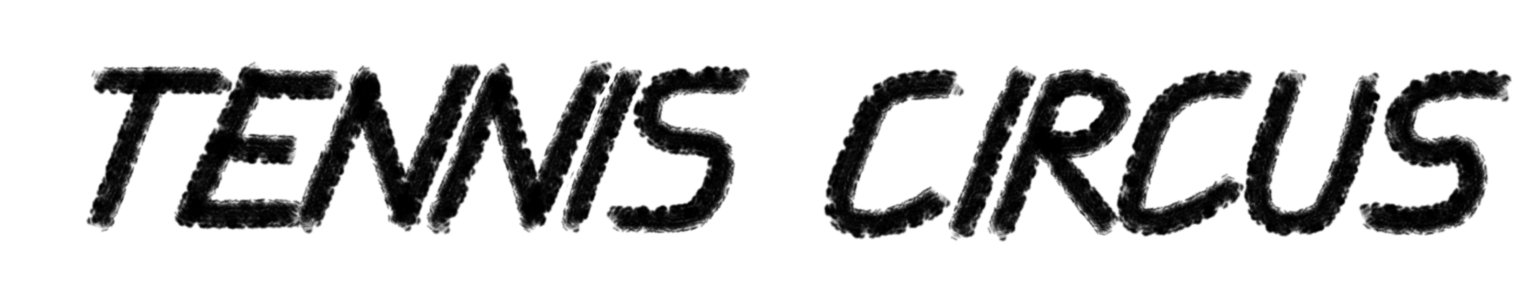









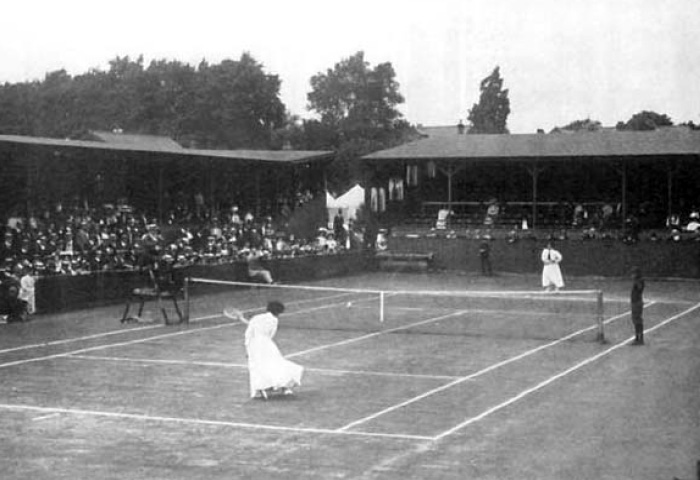







6 comments
Grande
Complimenti, che articolo.
MAI
Articolo bellissimo!
NO ROGER—NO TENNIS
Bellissimo articolo!